Ricordo dell’eroe Luigi Ferraro, medaglia d’oro e imprenditore
Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa, ma il ricordo della Medaglia d'oro Luigi Ferraro, genovese, pioniere della subacquea, eroe di guerra e poi brillante imprenditore, è ancora vivissimo, e non solo tra i congiunti, in particolare i figli Paolo e Italo. I quali, come ogni anno, si ritroveranno accanto a tanti amici ed estimatori del padre in occasione della messa di suffragio prevista per domenica nella cripta del Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria.
Sarà una ulteriore occasione per celebrare, in modo discreto, la figura di un combattente non solo in armi, ma anche nella vita civile, a favore di valori autentici. Un combattente, del resto, che si dichiarava orgoglioso di non aver «mai sparato a un italiano», compresi quei partigiani che - lui schierato nella Decima Flottiglia Mas, loro contro il fascismo - si era trovato di fronte in quella parte di conflitto che opponeva fratelli a fratelli.
È lo stesso Ferraro che nel maggio 1943 viene inviato in Turchia con l'incarico di compiere azioni di sabotaggio contro mercantili nemici, e, sotto falsa copertura diplomatica, di giorno si finge play boy amante della bella vita, ma di notte si trasforma in micidiale incursore subacqueo.
In quella «veste» - tuta, maschera e respiratore - conduce quattro azioni contro unità nemiche riuscendo ad affondarne due e danneggiando gravemente una terza. Le cronache del tempo riferiscono che «solo la quarta nave, regolarmente minata, sfuggì all'affondamento grazie a un'ispezione alla carena che consentì di rimuovere i bauletti esplosivi». Da qui il conferimento della più alta onorificenza al valor militare.
Ma Ferraro, nel dopoguerra, non si ammala certo di reducismo: fra l'altro, nel 1952 progetta la maschera «Pinocchio», la prima con la sagomatura per il naso, una concezione ancora oggi adottata e attualissima.
Poi, vengono le pinne «Rondine»
l'attività imprenditoriale della «Cressi Sub», la fondazione del Corpo Vigili del Fuoco Sommozzatori
la promozione di attività sportive, la consulenza e l'assistenza agli specialisti dei record di immersioni in apnea, e tanto altro ancora.
Fino a 92 anni, quando, ancora gagliardo e lucidissimo, si spegne nella sua casa genovese. Con negli occhi gli abissi profondissimi che aveva tanto amato ed esplorato.
Ricordo dell’eroe Luigi Ferraro, medaglia d’oro e imprenditore - Genova - ilGiornale.it

Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Personaggi memorabili
-
06-01-12, 00:06 #1Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Personaggi memorabili
Personaggi memorabili
-
18-01-12, 00:19 #2Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Rif: Personaggi memorabili
Rif: Personaggi memorabili
Spagna, adiós a Fraga
Morto a 89 anni il fondatore del Pp, ex ministro di Franco.
di Marco Todarello
Se c’era un uomo politico in grado di rappresentare, da solo, 60 anni di Storia della Spagna, questo era sicuramente Manuel Fraga.
Il senatore del Partito popolare, morto 89enne a Madrid nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio, ha vissuto da protagonista gli ultimi anni del franchismo, la transizione, la fondazione della democrazia e il federalismo autonomista.
Con la sua morte scompare l’ultimo anello di congiunzione tra l’attuale destra e la dittatura, l’unico politico dell’entourage del Generalissimo in grado di uscire indenne dalla dissoluzione del regime.
IN SENATO FINO ALL'ULTIMO.
Venerato e al contempo odiato, Fraga se n’è andato lasciando l’eredità di una vita nella quale tutti, compresi i suoi più acerrimi nemici, hanno dovuto riconoscergli un’eccezionale capacità politica. E sui banchi del Senato, aggrappato al suo bastone, si è seduto fino agli ultimi giorni, prima di morire con l’incarico di presidente onorario del Pp, attuale partito di governo.
Un animale del potere, che ha dedicato l'intera esistenza alla politica, «fino all’ultimo respiro», come aveva più volte promesso, rinunciando quasi del tutto alla sua vita privata.
MINISTRO CON FRANCO
Nato nel 1922 a Vilalba, paesino della Galizia rurale, Fraga fu da giovanissimo uno studente modello, mostrando abili capacità che lo portarono alla laurea in Diritto a 22 anni, alla cattedra universitaria a 26 e alla segreteria generale dell’Istituto nazionale di cultura a 29.
Uomo acuto e colto, da giovane cattedratico fu un acceso sostenitore delle teorie del giurista tedesco Carl Schmitt. A 40 anni Francisco Franco lo nominò ministro dell’Informazione e del Turismo.
AUTORE DELLA MODERNIZZAZIONE SPAGNOLA.
Il franchismo aveva intuito l’urgenza di modernizzare un Paese ancora troppo arretrato e isolato, e Fraga fu in un certo senso il simbolo della modernità in quella Spagna buia e chiusa al resto d’Europa.
Soppresse la censura preventiva della stampa, promosse la modernizzazione del linguaggio dei giornali e intuì l’importanza dei gesti pubblici in una società mediatica, come quando fece il bagno nel mare di Palomares, dove un aereo aveva perso un carico nucleare, per spegnere la paura collettiva.
Da attento controllore della stampa organizzò e gestì la propaganda del regime e fu lui a mettere la faccia quando si trattò di difendere episodi come la fucilazione del militante comunista Julián Grimau.

DAL 1969 CRITICHE AL FRANCHISMO.
Nel 1969 i tecnocrati che all’epoca dominavano il governo riuscirono a metterlo da parte. Da allora Fraga divenne il critico interno del franchismo, soprattutto dal 1973 quando, da ambasciatore a Londra, con quel dinamismo politico che fu una delle sue maggiori virtù creò una piattaforma di alleanze per assicurarsi un ruolo durante la transizione democratica. Nel primo governo post franchista, guidato da Arias Navarro, fu ministro dell’Interno.
Nella nuova Spagna provò a sviluppare il suo progetto politico, dove non mancavano le aperture e le novità, ma che puntava a rinnovare il franchismo senza alterarne le fondamenta.
La sua condotta politica era lì a dimostrarlo: fu lui a ordinare alla polizia di sparare sugli operai a Vitoria o sui manifestanti comunisti a Montejurra, un autoritarismo duro e puro che puntava a escludere qualsiasi partecipazione delle forze di sinistra alla vita politica.

OPPOSITORE DEL SOCIALISMO.
Nel 1978 accettò malvolentieri la nuova Costituzione e fondò Alianza popular (nel 1989 confluito nell’attuale forza di governo, il Pp), che voleva essere un partito conservatore di ispirazione democratica, ma dopo il crollo dell’Ucd (i cristiano democratici) rimase solo a combattere contro l’ampio consenso che il popolo spagnolo tributò ai governi socialisti negli anni 80.
Il premier socialista Felipe González rispettò il ruolo del vecchio statista fino a eleggerlo capo dell’opposizione. Rimase ai margini del parlamento e lasciò il testimone del partito a José Maria Aznar.

L’unica, grande frustrazione della sua vita fu non arrivare al posto in cui sembrava predestinato, e cioè la presidenza del governo. Era ostacolato dal suo passato franchista - che non rinnegò mai - e dovette accontentarsi del ruolo di governatore della Galizia.
Nella propria terra poté circondarsi di tutti gli attributi di un uomo di Stato, così da saziare la sua brama di guidare un Paese. Riuscì a rimanere al timone dal 1990 al 2005, e fu solo per la vecchiaia, e per l’ondata di impopolarità seguita alla catastrofe ecologica della petroliera Prestige, che perdette il consenso delle urne e fu costretto a rinunciare.
In Galizia ebbe il suo Stato ideale, costruito su misura.



Da critico del federalismo si trasformò in convinto autonomista e autore di proposte che più volte misero in imbarazzo il suo partito.
Dalla sua casa di Madrid ha visto l’esplosione della crisi economica e il passaggio del testimone tra l'ex premier José Luis Zapatero e l'attuale presidente del Consiglio Mariano Rajoy.


Proprio là, sullo scranno più alto della Moncloa, dicono i fedelissimi, si saranno concentrati i suoi ultimi pensieri. Sulla vetta più importante, l’unica che non era riuscito a conquistare.





-
13-02-12, 22:55 #3Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Rif: Personaggi memorabili
Re: Rif: Personaggi memorabili
L'uomo che per difendere la vita nascente si giocò il Premio Nobel
di Antonio Gaspari
E' stato un grandissimo scienziato.
Docente di genetica fondamentale all'Università di Parigi e membro
della Pontificia Accademia delle Scienze dal 1974, è stato il primo
presidente della Pontificia Accademia per la Vita.
Nel 1958 ha scoperto l'anomalia genetica (trisomia del cromosoma 21) che
causa la sindrome di Down, e la sua scoperta ha sconfitto le argomentazioni
razziste ed eugenetiche sui bambini che ne sono affetti. Si è battuto
coraggiosamente per la difesa della vita, sempre e ovunque. Il suo rifiuto
dell'aborto gli ha fatto perdere il Premio Nobel, ma la Chiesa cattolica
intende proclamarlo beato, nel frattempo in tanti lo ricordano come
il protettore dei disabili.
Stiamo parlando di Jérôme Lejeune, un uomo che con il suo coraggio ha
segnato la storia del movimento per la vita a livello mondiale. Era un
grande amico di Giovanni Paolo II ed era stato a pranzo con lui il giorno
in cui Ali Agca tentò di uccidere il Papa. Nel suo viaggio in Francia,
il Pontefice polacco si inginocchiò sulla sua tomba.
Per onorare una così grande persona, il Movimento per la Vita
(MpV) italiano ha promosso la pubblicazione di due libri:
"Il professor Lejeune - fondatore della genetica moderna",
scritto da Jean-Marie Le Méné, e "La vita è una sfida",
scritto da sua figlia Clara Lejeune, entrambi pubblicati
dalla Cantagalli di Siena.
Il MpV, insieme ai movimenti europei per la vita e la difesa
della famiglia, ha inoltre proposto di onorare la memoria del prof.
Lejeune con il Premio Madre Teresa di Calcutta.
Per la sua scoperta a soli 33 anni della causa della sindrome di Down, la
trisomia 21, Lejeune è considerato uno dei padri della genetica moderna.
Nel 1962 fu nominato esperto in genetica umana presso l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Nel 1964 venne nominato Direttore
del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Francia e nello stesso
anno fu creata per lui la cattedra di Genetica fondamentale nella Facoltà
di Medicina della Sorbona.
Dal punto di vista medico e per i suoi studi sulle patologie cromosomiche,
Lejeune venne nominato dottore honoris causa o membro di numerose altre
accademie e università straniere e ottenne prestigiosi riconoscimenti, fra i
quali il premio Kennedy nel 1962, il premio William Allan nel 1969 e il
premio Griffuel nel 1993 per i suoi studi sulle anomalie cromosomiche nei
tumori. Nel 1981 venne eletto all'Accademia di scienze morali e politiche e
due anni più tardi all'Accademia nazionale di medicina. Nel 1994 divenne il
primo presidente della Pontificia Accademia per la Vita creata da Giovanni
Paolo II.
Per tutto questo divenne il candidato numero uno al Premio Nobel per
la medicina, ma da quando, agli inizi del 1970, cominciò ad opporsi
all'aborto, divenne inviso ai poteri forti.
L'amore che portava verso i portatori della sindrome di Down divenne
centrale per fermare l'aborto. La sua battaglia da medica divenne civile
e pubblica. Fu il presidente onorario dell'associazione "SOS futures
mères" (il primo movimento "pro-life" francese), opponendosi all'aborto
e all'uso del mifepristone (la pillola abortiva), che definì il "primo
pesticida umano".
Lejeune sosteneva che "il feto è già un piccolo uomo" e in quanto tale,
anche quando è imperfetto, ha diritto alla vita, perché "compito del
medico è di guarire, non di uccidere", e "una società che uccide i suoi
figli ha perduto l'anima e la speranza".
Nel libro "La vita è una sfida", la figlia Clara racconta che una
trasmissione televisiva che nel 1972 - all'epoca del dibattito sulla nuova
legge per la legalizzazione dell'aborto - aveva grande ascolto sollevò per
la prima volta nel corso di un dibattito televisivo il problema dell'aborto
per i bambini che prima di nascere presentavano qualche handicap.
In quel momento l'unico handicap riconoscibile prima della nascita
era la trisomia. I genitori vivevano con apprensione, quasi fosse
una caccia al trisomico: "Che ha fatto di male il mio ometto perché
sopprimano quelli come lui?".
Clara ricorda che un giorno un ragazzo trisomico di dieci anni
si presentò allo studio di suo padre, piangendo in modo inconsolabile.
La mamma spiegò: "Ha visto con noi il dibattito di ieri sera".
Il ragazzo gettò le braccia al collo di Lejeune e disse:
"Vogliono ucciderci. Ci devi difendere. Noi siamo troppo deboli,
non sappiamo farlo da soli!". Da quel giorno Lejeune difese
anima e corpo la causa dei nascituri.
Il libro "La vita è una sfida" rammenta che il professore francese
chiamava i suoi malati "i diseredati": diseredati perché la loro eredità
genetica non era perfetta, perché erano i non-amati in una società
basata sull'apparenza. Vedendo quanto li amasse ci si poteva
chiedere come delle creature, per alcuni all'apparenza tanto
sgraziate, potessero ispirare tale tenerezza.
Cecilia, trisonomica, ha scritto a Lejeune: "Mio Dio, per favore
veglia sul 'mio amico'. Per la mia famiglia sono brutta assai,
lui mi trova persino carina; perché sa com'è fatto il mio cuore".
La battaglia di Lejeune gli venne fatta pagare cara dalla lobby antivita.
Il professore francese venne isolato dai colleghi della comunità
scientifica e venne attaccato duramente dai mezzi di comunicazione
di massa. Fu incompreso e perseguitato, e gli vennero tagliati i fondi
per la ricerca sull'acido folico per le mamme in gravidanza.
Ha raccontato la figlia Clara : "Bambini, avevamo un padre degno
di onori, scienziato geniale conteso dalle élites. Adolescenti, era diventato
un appestato: aveva commesso un delitto d'opinione. Adesso che rileggo
con occhi di adulta gli avvenimenti che hanno costellato la sua vita,
mi accorgo che ha dovuto soffrire molto. Ha conosciuto la rinuncia
alle cose del mondo, alla gloria, alla celebrità, ai riconoscimenti scientifici.
Ha conosciuto il tradimento di amici, il logorio amministrativo, la moderna condanna
esercitata dalla stampa. Se ha sofferto non l'ha mai fatto capire.
Davanti ai soprusi, sorrideva dicendo: Non combatto per me, allora
gli attacchi non hanno importanza".
In occasione di una riunione che cercava di giustificare l'aborto
con la scusa di evitare gli aborti clandestini, a New York, nella sede
dell'ONU, Lejeune - riferendosi all'Organizzazione Mondiale della Sanità –
disse: "Qui c'è un'istituzione per la salute che si è trasformata in un'istituzione
per la morte". Quella stessa sera scrisse a sua moglie e a sua figlia dicendo:
"Oggi mi sono giocato il mio Premio Nobel".
Il professore francese morì di cancro il 3 aprile 1994, giorno di Pasqua.
Lasciò la moglie Marie e cinque figli. Giovanni Paolo II, che lo conosceva,
lo frequentava e lo amava, il 22 agosto 1997 è andato a visitare la sua
tomba a Chalo-Saint-Mars, e in occasione della Giornata Mondiale
della Gioventù di Parigi ha scritto in una lettera al Cardinale Lustinger:
"Nel corso di tutta l'esistenza del nostro fratello Jérôme, questo richiamo
ha costituito una linea portante. Nella sua qualità di biologo, si è
appassionato alla vita. Nel suo campo è stato una delle massime autorità
a livello mondiale. Molti organismi lo invitavano a tenere delle conferenze
e sollecitavano il suo parere. Era rispettato anche da quanti non ne
condividevano le convinzioni più profonde".
"Desideriamo oggi ringraziare il Creatore, 'dal quale ogni paternità
nei cieli e sulla terra prende nome' (Ef 3, 15), per il particolare carisma
del defunto. Bisogna parlare in questo caso di carisma perché il professor
Lejeune ha sempre saputo far uso della sua profonda conoscenza della vita
e dei suoi segreti per il vero bene dell'uomo e dell'umanità e solo per
questo. È divenuto uno degli arditi difensori della vita, soprattutto
della vita dei bambini prima della nascita che, nella nostra civiltà
contemporanea, è spesso minacciata a tal punto che si può pensare
ad una minaccia programmata", aggiungeva il Papa.
Oggi questa minaccia si estende anche agli anziani e agli ammalati.
Le istituzioni umane, i Parlamenti democraticamente eletti, usurpano
il diritto di poter determinare chi ha diritto alla vita e chi può invece
vedersi privato di questo diritto senza alcuna colpa da parte sua.
In diversi modi, il nostro secolo ha sperimentato questo comportamento,
soprattutto durante la seconda guerra mondiale, ma anche dopo la fine
della guerra".
"Il professor Jérôme Lejeune si è assunto pienamente la responsabilità
specifica dello scienziato, pronto a diventare un 'segno di contraddizione'
senza tener conto di pressioni esercitate dalla società permissiva né
dell'ostracismo di cui era oggetto. Siamo oggi di fronte alla morte
di un grande cristiano del XX secolo di un uomo per il quale la difesa
della vita è diventata un apostolato".
Jerome Lejeune, il genetista più odiato dagli abortisti
Francesco Agnoli
Jerome Lejeune. In Italia di questo grande personaggio si sa molto poco. Gli unici quattro libri, a quanto mi consta, li ha pubblicati l’editore Cantagalli (l’ultimo è di Clara Lejenue, sua figlia: “La vita è una sfida”, Cantagalli). Nato nel 1926 a Montrouge sur Seine, Lejeune è colui che ha scoperto la prima anomalia genetica, la cosiddetta trisomia 21, cioè l’anomalia genetica che determina la sindrome di Dow. Sino alla sua scoperta si credeva che il mongolismo fosse una tara razziale, oppure che fosse determinato da genitori alcolisti o sifilitici. Lejeune dimostrò che non vi era nulla di disdicevole, nei genitori di quei bambini, nessuna degenerazione razziale, nessuna contagiosità, in quelle creature in cui era avvenuta la triplicazione di un cromosoma, un eccesso di informazione genetica.
Lejeune per questa scoperta, e per altre che la seguirono, ottenne innumerevoli riconoscimenti internazionali, premi ed onorificenze. Divenne un uomo famoso e per lui fu creata la prima cattedra di Genetica Fondamentale presso l’università di medicina di Parigi. Ma Lejeune non era solo un ricercatore, un curioso, uno studioso di segmenti di Dna che nel chiuso del suo laboratorio confonde la vita col codice genetico e che nell’entusiasmo delle sue scoperte crede di avere in pugno la totalità del reale. Il suo intento fu sempre quello di guarire i suoi malati, così socievoli, così allegri, così fanciulleschi. «Se si riuscisse a scoprire come poter curare la trisomia 21», scrive la figlia Clara, «allora sì la strada sarebbe aperta per poter curare ogni altra malattia genetica». Scoprire la prima aberrazione cromosomica è, nella mente di Lejeune, il primo passo per compiere l’opera del medico, che è, da sempre, quella di curare. Così anche la scoperta della diagnosi pre-natale, ad opera dell’amico di Lejeune, il professor Liley, originario della Nuova Zelanda, è collegata al desiderio di poter individuare quanto prima e curare più precocemente i bambini. Curare il prima possibile, in utero: è l’idea che entusiasma entrambi. Ma i due scienziati, che “si conoscono e si stimano”, “impotenti, assisteranno allo snaturamento delle loro scoperte”. Infatti nel 1970 in Francia la proposta di legge “Peyret” apre il dibattito sull’aborto, sull’eliminazione dei bambini che sono identificati come portatori di handicap già prima della nascita. “In quel momento”, ricorda Clara, “l’unico handicap riconosciuto prima della nascita è la trisomia!”. Lejeune, di fronte alla proposta Peyeret e al dibattito sull’aborto in generale, dinanzi alle menzogne sulla natura del feto o sul numero degli aborti clandestini, non riesce a tacere: sostiene la sacralità della vita, palesa il suo amore per i suoi piccoli malati, dinanzi a tutti, ovunque, arrivando ad affermare, all’Onu: “Ecco una istituzione per la salute che si trasforma in istituzione di morte”.
E’ coraggioso, ma non ingenuo: sa di aver intrapreso una strada pericolosa, di procurarsi, in questo modo, innumerevoli antipatie. La sera stessa del suo discorso all’Onu, scrive alla moglie: “Oggi pomeriggio ho perduto il premio Nobel”. Ed è proprio così. Non garba, a coloro che lo insultano, che gli sputano in faccia, a coloro che scrivono sui muri “A morte Lejeune e i suoi mostriciattoli”, che qualcuno rivendichi con carità e con forza la verità, e lo faccia con l’evidenza della scienza.
Per stroncare Lejeune le proveranno tutte: l’odio, le persecuzioni, le molestie anche fisiche, i controlli fiscali… Gli verrà negato l’avanzamento di carriera per ben 17 anni, verrà radiato dai congressi scientifici, gli verranno soppressi i crediti per la ricerca e negati i finanziamenti per i suoi pionieristici studi sull’acido folico per le mamme in gravidanza, che tanti bambini hanno contribuito a salvare dalla spina bifida e da altre patologie. Ma per fortuna il suo nome è famoso in tutto il mondo, e può continuare a lavorare grazie a sussidi americani, inglesi, neozelandesi. Il suo pensiero però è sempre fisso sui suoi cari trisomici, perché conosce l’insegnamento di Cristo: “ogni cosa che avrete fatto ad uno di questi piccoli, la avrete fatta a me”. In passato, ricorda Lejeune, i malati di rabbia venivano spesso uccisi e soffocati tra due materassi. Poi, un grande scienziato, Pasteur, liberò l’umanità da quella malattia.
[Il grande Pasteur, tra l’altro, era un cattolico che oggi verrebbe definito "integralista" o "bacchettone". Era solito dichiarare: "Ho la fede di un contadino bretone, ma, quando morirò, spero di avere la fede della moglie di contadino bretone".
 ]
]
Lejeune, nonostante varie difficoltà, continua a girare “il mondo, tiene conferenze e torna con riconoscimenti e borse di studio per i suoi collaboratori, finanziamenti per i programmi di ricerca”. Si batte in questi anni per evitare il disastro nucleare, viene inviato in Russia a parlare con Breznev sui rischi di un eventuale uso dell’atomica, e confuta il darwinismo materialista e ideologico di Jacques Monod, che riduce l’uomo ad un figlio del caso. In nome dei suoi studi di genetica Lejeune sostiene la credibilità di Adamo ed Eva e, anticipando di dieci anni le scoperte di Gould ed Eldrege, contrasta il gradualismo step by step di Darwin, sostenendo che l’evoluzione ha dovuto per forza fare dei salti.
In ogni cosa, come padre di cinque figli, come scienziato, come polemista contro l’aborto e il darwinismo materialista, ciò che più colpiva, in lui, come rammenta la figlia, era “l’assenza di paura. Non aveva paura. Cosa si può fare contro un uomo che non desidera niente per se stesso?”. Timete Dominum et nihil aliud, diceva, perché solo così si è veramente liberi, solo così si è certi di rinunciare a se stessi e al proprio egoismo, per perseguire con limpidezza la via della Verità e del Bene. Il suo motto poteva così essere quello che D’Annunzio, aveva ripreso e inciso sul muro del suo Vittoriale: “Ho quello che ho donato”.
Per questo, alla sua morte, un ragazzo down, Bruno, “con la sicurezza di un predicatore quaresimale, si impadronisce del microfono durante le esequie di Jerome Lejeune a Notre Dame di Parigi. Senza timore, in una cattedrale affollata, improvvisa un panegirico che termina con queste parole: ‘Grazie, mio caro professor Lejeune di quello che hai fatto per mio padre e per mia madre. Grazie a te, sono fiero di me’. Nessun altro oltre a Bruno avrebbe potuto dire parole simili. Più tardi veniamo a sapere che egli è il bambino il cui esame dei cromosomi, trentacinque anni prima, ha permesso a Lejeune di scoprire la trisomia 21” (Jean-Marie Le Méné, “Il professor Lejeune, fondatore della genetica moderna”, Cantagalli, Siena, 2008, p. 178)
Tutta la battaglia di Lejeune è dunque quella di un credente e di uno scienziato che in un’epoca in cui si fa fatica a riconoscere la dignità dell’uomo, il suo essere ad immagine e somiglianza di Dio, difende questo principio, con la sua umanità e la sua scienza, e urla al mondo che anche gli handicappati sono uomini. La sua, scrive Jean Marie Le Méné, è la stessa battaglia degli abolizionisti americani che di fronte alla schiavitù affermavano: a man is a man. Un uomo è un uomo. Negli stessi anni in cui Francis Crick dichiara che “nessun bambino dovrebbe essere definito come essere umano prima di essere stato sottoposto a un test che ne determini il corredo genetico. Se non supera il test, si è giocato il diritto alla vita”, Lejeune ribadisce: Ogni uomo è un uomo.
“E’ un feto, lo abortiamo? E’ un uomo. E’ malato? E’ un uomo. Fabbrichiamo un embrione in vitro? E’ un uomo. Lo congeliamo? E’ un uomo. Lo vivisezioniamo sino al quattordicesimo giorno? E’ un uomo. Lo produciamo in un utero artificiale, o in affitto? E’ un uomo. Lo cloniamo? E’ un uomo. Lo priviamo di suo padre e di sua madre, con l’adozione a persone dello stesso sesso? E’ un uomo” (Jean-Marie Le Méné, “Il professor Lejeune, fondatore della genetica moderna”, Cantagalli, Siena, 2008, p. 19)
Jerome Lejeune, il genetista più odiato dagli abortisti | UCCR




-
22-02-12, 23:40 #4Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
LA "VALCHIRIA" CHE DOVEVA UCCIDERE HITLER
MARCO SFERINI
Adolf Hitler studia le mappe che hanno segnate le direttrici di avanzata dell'Armata
Rossa ad est e quelle degli Alleati nel sud d'Italia. Accanto a lui i feldmarescialli
del Reich cercano il consiglio migliore da dare al dittatore che inizia ad affannare
sotto i colpi dei cannoni russi e dopo il fallimento di quello che doveva essere il suo
capolavoro: l'"operazione Barbarossa", la conquista della Russia sovietica.
Il giorno dell'attentato, Hitler si trova nella Prussia orientale, a Rastenburg, per fare
il punto della situazione sui vari fronti che gli alleati hanno aperto e stanno per aprire
contro quella che il fuhrer si ostina a ritenere "la fortezza Europa" dove, secondo lui,
gli alleati - dopo lo sbarco in Normandia - "non resteranno per più di nove ore".
Questa è una di quelle vicende dove forse si può ragionare anche con i "se e ma"
che la storia molto spesso non concede come metodo di interpretazione dei fatti
accaduti o che potevano essere e non sono stati.
I congiurati sono molti, quasi tutti ufficiali dell'esercito tedesco. Alcuni
derivano da nobili famiglie della Prussia preunitaria, e hanno per motto
che un "feldmaresciallo" non tradisce mai se non per via di eventi
eccezionali e tragici che possano mettere in pericolo la Patria tedesca.
I congiurati giudicano la politica di Hitler non soltanto folle, con
un atteggiamento che sarebbe a dir poco semplicistico nella valutazione,
ma soprattutto lesiva dell'onore del popolo tedesco, che "non potrà guardare
in faccia più gli altri popoli" continuando a considerarsi superiore
razzisticamente agli altri e sentendosi in diritto di violare il rispetto
dovuto agli altri popoli dell'Europa.
Claus Schenk Graf Von Stauffenberg, cattolico, è uno di questi ufficiali di stirpe
prussiana: morirà gridando al plotone d'esecuzione "Viva la nostra Santa Germania".
I congiurati erano degli aristocratici conservatori, che compresero appieno il rischio
per la Germania, una volta persa la guerra, di essere totale preda dei vincitori
e di essere pesantemente umiliata, anche con una divisione territoriale.
Come poi del resto fu.
Per evitare tutto questo, i comandanti tedeschi ribelli, che da mesi stavano
preparando l'operazione "Valchiria" (nata come un semplice piano di
addestramento in caso di rivolte nella capitale contro i lavoratori coatti
e ribelli di varia natura), avevano dalla loro una sempre più vasta rete
di resistenza al regime di Hitler. Generali, colonnelli e altri alti ufficiali uniti in una nuova
difficile prova: uccidere Hitler per potere quindi intavolare trattative con gli americani
e gli inglesi, con i russi e i francesi. E' l'idea che viene al generale Beck, al generale
Fromm, a von Tresckow e Olbricht. Tra loro c'è anche un ex ambasciatore di stanza
a Mosca, tale von der Schulenburg.
Regista dell'operazione viene ad essere il conte von Stauffenberg: ha 37 anni all'epoca
(siamo nel luglio del 1944) è di famiglia cattolica originaria del Baden-Wurttemberg.
Un bel ragazzo, atletico e prestante. Ha un viso che affascina tutti: i tratti del suo volto
- diranno i testimoni del fatto che stiamo raccontando - non erano solo gentili ma appariva
sempre sereno e calmo anche nei momenti di peggior nervosismo.
Insomma, Claus von Stauffenberg era tipo da saper tenere i nervi saldi.
Forse per questo viene scelto come esecutore del punto principale del piano
"Valchiria": collocare la bomba accanto ad Hitler. Dunque, uccidere
il fuhrer. La fase seconda dell'operazione prevede l'occupazione di Berlino
e l'instaurazione di un nuovo governo. Il capo dello Stato sarebbe
divenuto ad interim il generale Beck e il generale Goerdeler avrebbe
assunto il ruolo di Cancelliere del Reich.
La protezione più alta che i congiurati hanno viene da tre grandi nomi,
tre grandi feldmarescialli temuti e riveriti: Rommel ("la volpe del deserto"),
Kluge e Witzleben. L'occupazione della capitale implica anche l'ovvio
presidio della radio del regime e l'arresto di tutti i capi della Gestapo
e delle SS. Eguali ordini vengono diramati a tutti i comandanti congiurati
in Francia e nei Paesi Bassi.
Stauffenberg parte la mattina del 20 luglio 1944 alle 7,30 del mattino.
Sorvola Berlino e si dirige alla "wolfsschanze", ossia alla "tana del lupo".
Per meglio comprendere alcune difficoltà nell'esecuzione del piano, va detto
che il conte prussiano è rimasto ferito sui campi di battagia, e ha l'uso
parziale di una sola mano, mentre l'altra è praticamente un moncherino.
Una sua parente ricorderà anni dopo che Claus aveva difficoltà notevoli
nel maneggiare ogni tipo di strumento. Gli rimaneva persino difficile infilarsi
il cappotto.
Quella mattina nella Prussia orientale splende un bel sole che filtra anche
tra gli alberi di quella fitta foresta dove si trova il quartier generale
di Hitler. "Sembrava qualcosa che stesse a mezzo tra un convento
e un campo di concentramento", dirà di quel luogo il generale Jodl
a Norimberga. Lo stesso che firmerà la resa incondizionata della Germania
nelle mani dei comandanti alleati e dell'esercito sovietico.
In questa specie di convento alberato Stauffenberg arriva alle 12,30 e,
dopo i rituali dell'occasione, va nella baracca di legno e muratura dove
si trova la riunione degli stati maggiori con Hitler: Keitel, Jodl, Warlimont,
il colonnello Brandt e altri ufficiali superiori delle SS. Ci sono guardie
del corpo del fuhrer e un gruppo di stenografi. Quando Stauffenberg
entra, Hitler gli rivolge un saluto striminzito, distratto dall'ascolto
del rapporto sulla situazione del fronte russo meridionale.
Sono momenti da cardiopalma: il conte Stauffenberg depone una borsa
sotto il tavolo della riunione. Contiene l'esplosivo: una massa di grigio
plastico inglese con un detonatore azionato a molla da un acido che
corrode il filo di acciaio che lo blocca. Ne ha portato con sé quasi 1 kg,
per l'esattezza 890 grammi. Ma non riuscì a collocarlo tutto, solamente
la metà. Qui potremmo inserire un "se": se la bomba fosse stata preparata
con tutto l'esplosivo avrebbe avuto certamente un impatto duplice di quello
ottenuto e, nonostante facesse caldo e le finestre fossero aperte e quindi
l'impatto della detonazione potesse in qualche modo essere attutito da ciò,
di certo non vi sarebbe stato scampo per molti in quella saletta piccola
dove Hitler seguiva i rapporti dei suoi generali.
La borsa ora si trova sotto il tavolo. Qualcosa non va: il generale Brandt
trova impaccio in quella borsa. Prima la sposta con un piede e poi la prende
e la colloca più lontano da dove si trova Hitler. E' questione di centimetri,
ma questo spostamento salverà la vita al fuhrer.
"Devo uscire a fare una telefonata". Stauffenberg esce e si reca veloce
su un auto già disposta che lo porta fuori dalla zona dell'esplosione.
Avviene alle 12,42 e uccide quattro ufficiali. Uno di questi è il generale
Brandt. Ma Hitler, protetto da una parte del tavolo molto spesso, si salva.
Ha solo qualche contusione e graffio, ma non riporta alcuna ferita. Gli fa
male il braccio destro, parzialmente paralizzato, ma è un trauma momentaneo.
Stauffenberg è certo che Hitler è morto, ma alle sei di sera, quando rientra
a Berlino scopre che nessuno ancora ha dato la notizia dell'attentato.
Non solo questo impedisce una rapida attuazione del piano "Valchiria", ma
la radio diffonde la notizia che il fuhrer è stato oggetto sì di un attentato,
ma che è vivo e vegeto e che sta bene. I congiurati danno l'ordine
di occupare Berlino: si comincia dai ministeri. Il maresciallo Otto Remer
viene incaricato di ciò. Va da Goebbels che, per tutta risposta e per nulla
intimorito lo mette a colloquio telefonico con Hitler medesimo: "Lei
riconosce la mia voce maggiore?", dice Hitler a Remer. Questi risponde
affermativamente. "La nomino colonnello e le ordino di reprimere questa
rivolta con la più spietata energia". Il battaglione fa dunque dietrofront
e va contro i congiurati questa volta.
La "Valchiria" crolla in poche ore: il generale Beck si suicida. Appena
saputo che Hitler è ancora vivo, il generale Romm cambia immediatamente
campo e fa arrestare i congiurati rimasti. Vengono condotti nel cortile:
ci sono il conte Claus von Stauffenberg, Olbricht e altri ufficiali.
Il plotone d'esecuzione ha la scena illuminata dai fari dei camion
che si sono messi davanti ai condannati a morte: una, due, tre scariche
di fucili e cadono a terra.
Ma neppure l'ipocrita Romm scamperà dalla furia di Hitler: la repressione
successiva del tentato colpo di stato viene repressa nel sangue più crudo
nelle settimane successive e non lo risparmierà.
Se l'attentato fosse riuscito? Possiamo dire che forse la Germania avrebbe
potuto evitare ad esempio il rogo di Dresda e gli ulteriori bombardamenti
su Berlino che la resero un campo aperto di macerie. Possiamo di certo
affermare che gli alleati l'avrebbero punita con mutilazioni territoriali,
magari riportandola ai confini antecedenti l'invasione della Polonia, ma
che non avrebbe subìto la divisione in due settori, in due stati. La linea
di confine della DDR con la Repubblica Democratica Tedesca era esattamente
quella raggiunta dagli eserciti alleati e dall'Armata Rossa. Al momento
dell'attentato, infatti, la Germania non era ancora stata occupata dalle
truppe alleate e sovietiche che stavano solamente portando indietro
una linea di fronte precedentemente fatta avanzare da Hitler.
Questi sono forse gli unici "se" che possiamo dire.
Del resto non possiamo certo sapere: che sarebbe accaduto ad esempio
ai campi di concentramento? E alla guerra con l'URSS?
I congiurati, infatti, erano disposti solamente a trattare con americani
e inglesi, non con i sovietici.
Quei tedeschi che non volevano Hitler
Il Timone n.76 settembre-ottobre 2008
Non tutta la Germania parteggiò per Hitler. Fra chi si schierò contro ci furono
ufficiali dell'esercito che organizzarono un attentato per eliminare il tiranno.
Che però fallì e provocò una sanguinosa repressione
di Luciano Garibaldi
Molti ricordano il film, trasmesso anche dalla nostra televisione, La rosa
bianca, che il regista tedesco Mare Rothemund volle dedicare alla vicenda
dei fratelli Hans e Sophie Scholl, studenti dell'Università di Monaco di
Baviera, decapitati perché avevano osato distribuire volantini di dura
critica a Hitler. La commovente vicenda della Weisse Rose (la rosa bianca),
il movimento cui i fratelli Scholl avevano dato vita, va inquadrata
nell'ambito della resistenza cattolica al nazionalsocialismo.
Come morirono i fratelli Scholl? Nel febbraio 1943, il Gauleiter della
Baviera, Paul Gieser, al quale erano state consegnate alcune lettere della
Weisse Rose duplicate con il ciclostile e inviate a migliaia di tedeschi con
la denuncia dell'empietà e dei crimini del regime, a cominciare dalla
persecuzione antiebraica, decise di affrontare i «ribelli» nel loro «covo».
Tenne un discorso all'Università, un discorso volutamente volgare,
contenente l'invito agli studenti ad andare a combattere «anziché perdere
il loro tempo sui libri», e alle studentesse «a rendersi utili, magari
regalando un figlio all'anno al Terzo Reich».
«Non dubito minimamente», proseguì, «che le più carine troveranno
un uomo con cui accoppiarsi. Per le racchie, offro la mia scorta di SS».
Era davvero troppo. Il Gauleiter fu coperto di fischi e le SS scaraventate
a calci fuori dall'aula magna. Quel pomeriggio, diversi cortei di studenti
percorsero le vie del centro, aggredendo le SS e la polizia.
In serata due divisioni corazzate ristabilirono l'ordine a raffiche
di mitraglia. I fratelli Scholl (lui venticinquenne, studente di medicina,
lei ventunenne, iscritta a biologia), riconosciuti quali capi
dell'insurrezione, furono arrestati e decapitati con una mannaia.
Li seguì sulla forca l'ispiratore del gruppo, il professor Kurt Huber
(1893-1943), titolare di filosofia teoretica e profondamente cattolico.
Nella sua ultima lettera scrisse: «La morte è la bella copia della mia
vita».
La resistenza cattolica
Dopo l'istituzione della dittatura (23 marzo 1933, con l''«Ermaechti-gungsgesetz»,
la legge sui pieni poteri), nonostante il regime di terrore e di violenza, si sviluppò,
nei vari strati della popolazione, una opposizione che andava dal non allineamento
fino al segreto aiuto prestato agli ebrei perseguitati; dalla critica fino al complotto
attivo. Schierata in primo piano contro il regime troviamo la Chiesa cattolica.
L'enciclica Mit brennender Sorge di papa Pio XI, del 18 marzo 1937,
suonò chiara ed inequivocabile condanna del nazismo, bollato
come ideologia pagana e razzista.
Subito dopo, per ordine di Hitler, le associazioni cattoliche furono
sciolte, i direttori delle loro riviste arrestati e sovente condannati
a morte, decine di ecclesiastici sottoposti a persecuzioni grottesche
(processi-farsa per frodi valutarie o atti di immoralità furono imbastiti
contro vescovi e semplici parroci), conventi e beni ecclesiastici
confiscati, secondo un canovaccio direttamente mutuato dai giacobini
della Rivoluzione francese e fatto proprio anche dai regimi comunisti.
Ciononostante, il vescovo di Munster, conte Clemens August von Galen
(1878-1946), trovò il coraggio, nel 1941, di pronunciare un'omelia «contro
le persecuzioni razziali, la folle eutanasia, gli arresti indiscriminati,
la violazione dei più elementari diritti umani».



Intanto, gesuiti celebri come padre Alfred Delp

e padre Augustin Roesch, provinciale della Compagnia di Gesù in Baviera,
divennero le guide spirituali del Circolo di Kreisau, da dove uscirà il colonnello
Klaus von Stauffenberg, l'attentatore del 20 luglio 1944...
Accanto ai militari della vecchia nobiltà prussiana, ma anche eroi di guerra
come il feldmaresciallo Erwin Rommel (1891-1944), agirono per farla
finita col nazismo gli esponenti di punta che avrebbero dovuto dar vita
alla nuova Costituzione e formare il nuovo governo: uomini come
Cari Goerdeler, che nel 1937, inascoltata Cassandra, aveva dato inizio
a una serie di pellegrinaggi attraverso l'Europa e l'America nel vano
tentativo di mettere in guardia le democrazie occidentali sul pericolo
rappresentato dal nazismo, o come Herbert von Bismarck, già
sottosegretario agli Interni, e Ulrich von Hassel, ex ambasciatore a Roma.
Determinante, per l'elaborazione dei programmi del futuro governo, e per
la sua funzione di collegamento con i vari gruppi di opposizione, si rivelò
il Circolo di Kreisau, dal nome della proprietà, in Slesia, del conte Helmuth
von Moltke (1907-1945). Qui si riunivano, durantegli anni della dittatura,
giovani intellettuali, tra cui Peter York von Wartenburg, Adam von Trott zu
Solz, lo stesso Von Stauffenberg, che di York era cugino primo. Furono essi
a gettare il seme che poi germoglierà nelle file della resistenza.
«Il nostro problema», scriveva Von Moltke nei suoi Pensieri, «è quello
di ricostruire un uomo europeo». E in una lettera all'amico americano Lionel
Curtis: «Oggi, per una parte del popolo tedesco, incomincia ad apparire
chiara non che essi sono stati fuorviati, non che la guerra può finire con
una sconfitta, ma che è peccato quel che sta accadendo, e che personalmente
sono responsabili per ogni orribile azione che sia stata commessa,
naturalmente non in senso terreno, ma come cristiani».
E Von Moltke aggiungeva: «Un solo pensiero: quello del cristianesimo
come unica ancora di salvezza nel caos».
Bisognava - secondo l'appello che Goerdeler avrebbe rivolto al popolo
dalla radio - «purificare il nome tedesco più volte disonorato. Solo
noi tedeschi possiamo farlo. E lo faremo».
Perciò, tribunali tedeschi avrebbero giudicato «coloro che hanno
screditato la nostra patria facendone la caricatura di uno Stato»,
mentre i più gravi «delitti internazionali» (come la persecuzione
antiebraica) sarebbero stati giudicati dalla Corte di Giustizia dell'Aia,
composta da sei giudici: tre appartenenti ai Paesi vincitori, due neutrali
e un tedesco. Una Norimberga molto serena ed accettabile di quella poi
realizzatasi ad opera dei vincitori. Invece, fallito l'attentato, Hitler
farà mettere a morte settemila persone, tra cui tutti i capi della
resistenza, nessuno dei quali volle riparare all'estero.
Von Stauffenberg e il mistero della confessione
Ho cercato di portare luce su uno degli enigmi che, ormai da più di 60 anni,
gravano sulla vicenda: se cioè la Chiesa fosse al corrente dell'attentato
e ne avesse dato un implicito assenso. Il primo a parlarne fu Constantine
Fitz Gibbon, storico irlandese, uno dei massimi studiosi del 20 Luglio.
Nel suo libro Shirt of Nessus (Londra, 1956), sostenne che Von Stauffenberg
si confessò dall'arcivescovo di Berlino, cardinale conte Konrad von Preysing
(1880-1950), senza tuttavia ricevere l'assoluzione. L'arcivescovo gli avrebbe
però detto che «non si considerava autorizzato a trattenerlo in base a motivi
ideologici» (p. 159).
Una decina d'anni dopo, da me intervistato a Berlino durante l'inchiesta
giornalistica che condussi sull'attentato, padre Harald Pòlchau, il
cappellano del carcere di Tegel che aveva assistito, in punto di morte,
i massimi esponenti del complotto, tra cui Von Moltke, Alfred Delp,
Julius Leber, York von Wartenburg, Von Hase e Von Witzleben, mi disse
di avere appreso da quei condannati, senza ombra di dubbio, che Von
Stauffenberg si era confessato, aveva ricevuto l'assoluzione e si era
anche comunicato.
Appare in ogni caso assai verosimile che l'arcivescovo Von Preysing (il quale
sarà nominato cardinale da Pio XII nel marzo 1946 assieme al vescovo, già
perseguitato dai nazisti, conte Clemens August von Galen) abbia prontamente
e doverosamente comunicato alle gerarchie superiori ciò che aveva appreso
da Stauffenberg.
Nel 1963 fu inaugurata a Berlino, nel quartiere operaio di Siemensstadt,
la chiesa cattolica Regina Martyrum, edificata in memoria dei religiosi
impiccati in seguito ai fatti del 20 Luglio 1944. All'inaugurazione era
presente il cardinale Julius Dòpfner, attorniato dai vescovi della Germania.
Tutti dissero che, avendo fatto costruire quel tempio, la Chiesa di Roma
aveva ammesso la liceità del tirannicidio.
Avvenire
Stauffenberg e gli altri martiri dell'attentato al Führer
di G. Sant.
Lo sfortunato attentatore alla vita di Adolf Hitler era un cattolico
praticante. Claus Schenk von Stauffenberg era infatti nato nel 1907
da una famiglia molto religiosa della Germania meridionale, con ascendenze
però nell'aristocrazia prussiana.
In età giovanile fece parte della cerchia del poeta Stefan George, influenza
che ritornerà nei giorni precedenti l'attentato. Alcuni suoi conoscenti,
infatti, hanno testimoniato gli accenti quasi metafisici che ormai
il militare dava al gesto che stava per compiere. Recitava alcuni versi
di una poesia di George, «L'Anticristo»: «Voi giubilate, incantati dalla diabolica
apparenza, dilapidate quel che è rimasto della passata sostanza, e avvertite
il pericolo solo prima della fine».
Stauffenberg era a contatto con molti altri credenti, compresi alcuni gesuiti,
che facevano parte del «circolo di Kreisau», oggetto di una violenta repressione
dopo l'attentato. Una reazione che fece almeno cinquemila vittime, fra le quali
alcuni santi e beatificandi della Chiesa: Nicolaus Gross e il gesuita Alfred Delp,
Bernhard Letterhaus, e vecchi appartenenti al partito cattolico del Zentrum,
come Josef Wirmer ed Eugen Bolz.
[Partecipò alla congiura pure il celebre scrittore Ernst Junger, che in seguito
si convertì al cattolicesimo

]


/







-
29-02-12, 23:00 #5Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
Cile: dai libri di scuola scompare la parola “dittatura”
di Redazione.
Sta facendo discutere la decisione del ministero dell’Educazione del nuovo governo cileno di Sebastian Piñera di sostituire la parola “dittatura”, in riferimento al periodo di governo del generale Augusto Pinochet, con il termine “regime militare”.
Il ministro dell’Educazione del Cile, Harald Beyer, ha confermato ieri che il governo ha modificato i libri di testo base delle scuole elementari. Beyer, nominato la scorsa settimana dopo le dimissioni del suo predecessore Felipe Buldes, ha spiegato ai giornalisti che si è scelto di “usare la definizione più generale che è regime militare al posto di dittatura”. Nei libri di testo quindi scomparirà il periodo storico finora indicato come “dittatura cilena” per essere sostituito da “regime militare”.
Secondo il ministro, il nuovo testo “intende comparare differenti visioni sul fallimento della democrazia in Cile, sul regime militare e sul processo di recupero della democrazia iniziato alla fine del ventesimo Secolo, considerando i vari protagonisti, le differenti esperienze e punti di vista”.
Difendendo la decisione, Beyer ha spiegato che la modifica del termine è passata attraverso tutte le istanze regolari incaricate di valutare la questione e ha avuto l’approvazione del “Consiglio Nazionale dell’Educazione trasversale, che lo ha approvato senza modifiche”.
La modifica, realizzata attraverso un processo al quale partecipano molti educatori, “non ha niente a che vedere – ha aggiunto il ministro – con la polemica tra sostenitori e detrattori, ma con espressioni che si usano abitualmente in questo tipo di testi, in molte parti del mondo”.
“Quello di Augusto Pinochet non è stato un governo democratico, ma anche un regime militare ha questa accezione” ha concluso il ministro.
L’epoca di Pinochet è stata sempre definita finora dittatura e colpo di Stato e, come ricordano i media cileni, lo stesso generale era solito riferirsi al suo governo come a una “dictablanda”, ovvero a una “blanda dittatura”, con un gioco di parole in spagnolo tra “dictadura” e “dictablanda”.
I Chicago Boys all’opera
Elena Comelli
La strada più diretta per arrivare a Santiago parte da Vienna e passa per Chicago. Ma l’anno di partenza non è il 1973. È nel settembre del 1923, esattamente mezzo secolo prima, che Friederich von Hayek sbarca a Manhattan con in tasca due lauree dell’università di Vienna – in Economia e in Giurisprudenza – deciso a conseguire un dottorato alla New York University. Tipico prodotto dell’impero austro-ungarico, il ventiquattrenne Friedrich viene da una famiglia di biologi e funzionari governativi, ma è stato travolto come suo cugino Ludwig Wittgenstein dalla Prima guerra mondiale e dal collasso dell’impero mentre camminava spedito verso un’ordinata carriera di botanico. Dopo la guerra, in cui ha combattuto da ufficiale in battaglie dove i suoi uomini «parlavano undici lingue diverse» (secondo il suo stesso resoconto), Friedrich torna a Vienna socialista convinto e decide di mettere le sue competenze al servizio della costruzione di un’organizzazione sociale più giusta, contro ogni nazionalismo. Mentre la vibrante società viennese d’inizio secolo, in cui era cresciuto, si sfalda, Friedrich studia come un matto Economia e Giusrisprudenza, deciso a mollare gli ormeggi appena possibile verso il Nuovo Mondo.
Lo sbarco a New York nel settembre del 1923 è fondamentale per la formazione di Hayek, ma in un certo senso si rivela una falsa partenza: il suo interesse per l’economia si rafforza, ma ben presto gli mancano i soldi per mantenersi ed è costretto a tornare a Vienna. Qui, sotto l’influenza di Ludwig von Mises

esponente di punta della Scuola austriaca del pensiero economico, si converte al liberalismo e all’economia di mercato. Nel 1931, dopo essere stato per anni assistente di Mises, Hayek viene chiamato da Lionel Robbins a insegnare alla London School of Economics, un bastione di sinistra dove però il dipartimento di macroeconomia sta virando su posizioni liberiste, contro il dominante influsso statalista di John Maynard Keynes.

Con l’avvicinarsi della Seconda guerra mondiale, Hayek è sempre più preoccupato dallo statalismo e dal nazionalismo rampanti nel Vecchio Continente. In uno dei suoi articoli più profetici, pubblicato in quegli anni, spiega il fallimento delle economie pianificate centralmente con la famosa teoria della conoscenza: chi sta al centro non ha tutte le informazioni necessarie per prendere delle decisioni economiche. Solo il «meraviglioso sistema dei prezzi», spiega, «è un meccanismo perfetto per comunicare informazioni con la velocità del vento anche nelle regioni più remote». Ecco perché in ogni caso bisogna lasciarli fluttuare liberamente.
Questa e altre sue teorie vengono condensate in un libro ferocemente antistatalista, The Road to Serfdom, oggi considerato la pietra angolare del neoliberismo all’austriaca. Ma nel regno di Keynes era impossibile pubblicarlo. È così che si crea per la seconda volta un proficuo cortocircuito fra il rigido ufficiale austroungarico e il Nuovo Mondo, dove tutto è possibile. Nel 1944 il libro di Hayek viene pubblicato dalla Chicago University Press su indicazione di Aaron Director, docente di Economia e genero di Milton Friedman, economista di punta dell’ateneo. Il libro scoppia come una bomba nel mondo accademico e in breve diventa un bestseller. Il giovane Friedman (più tardi consigliere economico di Ronald Reagan e infine premio Nobel per l’economia nel 1976, due anni dopo Hayek), lo legge.
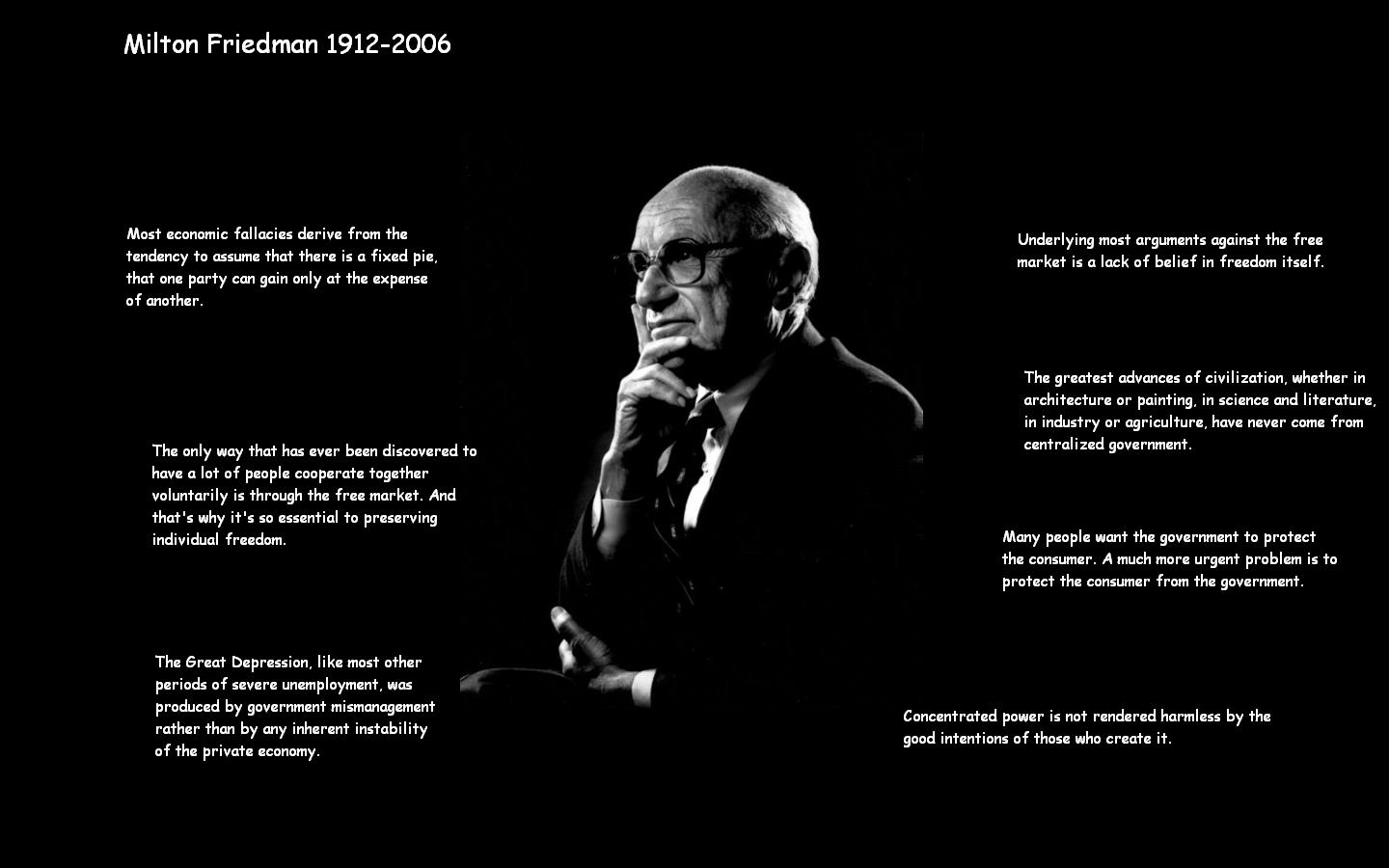

Poco dopo il volume finisce avventurosamente fra le mani di una studentessa dell’università di Oxford, Margaret Roberts, non ancora Margaret Thatcher.

Keynes lo legge mentre è in viaggio per il vertice di Bretton Woods, dove verrà deciso l’assetto economico del mondo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. In una memorabile lettera al suo acerrimo nemico, lo definisce cavallerescamente «un grande libro», ma ribadisce la sua incrollabile fiducia nella pianificazione centralizzata dell’economia: «Semmai ce ne vorrebbe di più», scrive Keynes, «non certo di meno». E aggiunge: «Se solo potessi indirizzare la tua crociata in questa direzione, eviteresti la figura di Don Chisciotte che stai facendo adesso».
Dopo la Prima guerra mondiale e specialmente dopo la Grande Depressione tutto il mondo si era mosso quasi all’unisono verso una maggiore pianificazione centrale dell’economia, a partire dal blocco socialista per arrivare all’America Latina, passando per l’Europa continentale e perfino per il Nord America. Il protezionismo nazionalista dilagava, con dazi altissimi per impedire le importazioni e schermare le industrie locali dalla concorrenza estera, con regolamentazioni sempre più stringenti sui prezzi che portavano al boom del mercato nero, con vaste nazionalizzazioni delle industrie principali e un mercato del lavoro sempre più rigido.
In questo contesto, la crociata di Hayek contro lo statalismo e a favore del libero mercato, per un ritorno alla visione classica dell’economia ancorata negli insegnamenti di Adam Smith, sembrava davvero una battaglia contro i mulini a vento. Eppure oggi sappiamo che il vento, all’insaputa di tutti, già allora stava girando nella direzione indicata da Vienna. La globalizzazione, frutto dell’apertura dei mercati locali alla concorrenza internazionale, della deregulation reaganiana, delle liberalizzazioni à la Thatcher e del crollo dell’impero sovietico, discende direttamente dalle teorie di Hayek. E la prima tappa nella nuova direzione, per una serie di coincidenze fortuite, è Santiago. Ma prima ancora di arrivare là, si passa da Chicago.
Hayek abbandona la London School of Economics per l’università di Chicago nel 1950. Gli viene affidata la cattedra di Scienze sociali, che non fa parte del dipartimento di economia, ma l’interazione con gli economisti è vivace e il rapporto con Milton Friedman, diventato nel frattempo il padre del neoliberismo americano, sempre più stretto. È qui che Hayek scrive la sua opera più importante, The Constitution of Liberty, pubblicata nel 1960, dove si afferma che il laissez-faire non è sufficiente ad assicurare un buon funzionamento dell’economia e che il ruolo più importante dello Stato sta proprio nello sviluppo di leggi e regole capaci di assicurare la libera concorrenza. Un’affermazione che oggi sembra banale, ma allora suonava del tutto nuova e rivoluzionaria. Negli stessi anni il Nobel Theodore Schulz, rettore dell’Università di Chicago, e Julio Chana, rettore dell’Università cattolica di Santiago, instaurano un rapporto di collaborazione molto stretto fra i due atenei, aprendo un ponte fra Santiago e Chicago per tutti gli studenti cileni di economia interessati ad ampliare le proprie conoscenze.
Negli anni Sessanta lo stesso canale, che presuppone un importante aiuto economico agli studenti stranieri, viene aperto anche con l’Argentina. Al Harberger, un collega di Friedman che ha dedicato tutta la sua vita al progetto sudamericano, lo descrive così: «Ora i latinos possono andare dappertutto, ma allora non era così. Negli anni Sessanta, mentre a Chicago si potevano trovare anche 40 o 50 studenti sudamericani in corsa per il dottorato su una popolazione complessiva di 150-180 neolaureati, a Harvard ce n’erano forse tre o quattro, al Mit cinque o sei. È la nostra politica delle ammissioni che ha fatto diventare Chicago così importante sulla scena sudamericana: eravamo pronti ad ammettere anche studenti che avrebbero potuto fallire lungo il cammino, mentre le altre grandi università americane ammettono praticamente solo studenti in grado di garantire fin dal primo giorno il raggiungimento di un dottorato al top dei voti». In una decina d’anni, il canale aperto con l’America Latina ha portato a Chicago oltre trecento studenti, di cui in tempi diversi 25 sono diventati ministri, 12 governatori della Banca centrale del proprio Paese e gli altri sono andati via via a riempire tutti gli scaglioni più elevati delle varie istituzioni economiche del continente. A partire dalla fine degli anni Sessanta i cosiddetti Chicago Boys, molto influenzati dall’impostazione neoliberista dell’ateneo di Friedman e Hayek, erano pronti ad agire.
I loro Paesi d’origine non erano certo terre vergini. Fin dagli anni Trenta tutti gli economisti del mondo guardavano con molto interesse al cono Sud del continente americano, compreso John Maynard Keynes, più volte ospite a Buenos Aires del suo allievo Raul Prebitsch, allora governatore della Banca centrale argentina. Le teorie keynesiane di Prebitsch, dal 1950 direttore dell’Ecla (Economic Commission for Latin America), un’emanazione dell’Onu con sede a Santiago, hanno dominato completamente la scena economica sudamericana per quasi mezzo secolo. I leader del continente, pur di opposte tendenze politiche, erano infatti concordi sull’approccio di base sviluppato da Prebitsch, chiamato «dependencia». L’economista argentino divideva il mondo in un centro e una periferia, con il centro nei Paesi industrializzati (Europa e Nord America), dove ha origine l’innovazione tecnologica, e la periferia negli altri Paesi, produttori di materie prime, che nell’interscambio commerciale fra i due contraenti risultano sempre perdenti. Per emancipare i produttori di materie prime dalla dipendenza dai manufatti importati dall’estero – sosteneva Prebitsch – basta ostacolare le importazioni alzando insormontabili barriere commerciali, nazionalizzare la produzione di materie prime e con i proventi delle esportazioni costruire da zero un’industria nazionale. La sua teoria, perfettamente in linea con le impostazioni autarchiche dei fascismi europei, ma anche con la battaglia per l’industrializzazione dell’Unione sovietica, è stata applicata alla lettera dai regimi sudamericani di destra e di sinistra, da Juan Peron a Fidel Castro, passando per Eduardo Frei, presidente cileno dal 1965 al 1970 e nazionalizzatore delle importanti miniere di rame, allora in mani statunitensi.
Dall’Argentina al Cile, dall’Uruguay al Brasile, dal Messico alla Bolivia, uno a uno i confini nazionali venivano inchiavardati da dazi che negli anni Cinquanta e Sessanta raggiungevano livelli del 3-400 per cento, con l’assurda conseguenza di proteggere dalla concorrenza estera impianti produttivi spesso completamente inefficienti e di costringere gli abitanti dell’America Latina a pagare i manufatti locali il doppio o il triplo di quel che avrebbero speso per gli stessi prodotti importati dall’estero. L’inflazione rampante costringeva i governi sudamericani a mettere in circolazione un’enorme massa di denaro e a indebitarsi fino al collo proprio da quegli stessi Stati da cui volevano rendersi indipendenti. La politica di socializzazione dell’apparato produttivo cileno, inaugurata da Salvador Allende nei suoi anni di governo, non è altro che l’applicazione fino alle estreme conseguenze delle teorie di Prebitsch. Le espropriazioni delle industrie, le imposizioni di salari e prezzi fissati dall’alto e più in generale la distribuzione statalistica di una ricchezza che non veniva creata – con le conseguenti enormi spinte inflazioniste, il boom del mercato nero e il crescente malcontento di quel 62 per cento della popolazione che non aveva votato Allende – sono l’effetto della diffusa convinzione che le leggi del mercato possano essere semplicemente abolite costruendo un alto muro lungo i confini nazionali.
È in questo contesto particolarmente ostile alla loro impostazione liberale che i Chicago Boys cileni si trovano a operare. Animati dalla convinzione che le teorie di Prebitsch stiano portando il Paese alla rovina, i giovani economisti concepiscono una piattaforma economica per il candidato della destra, Jorge Alessandri, battuto da Allende alle elezioni del 1970. Malgrado la sconfitta, i Chicago Boys continuano a incontrarsi tutti i martedì sera a Santiago e ad aggiornare le loro proposte.
È grazie a questa piattaforma, chiamata “Il mattone” per quanto era diventata voluminosa nel frattempo, che dopo il colpo di stato di Pinochet, all’inizio del 1975, il gruppo viene contattato da Ricardo Hausmann, un uomo politico legato alla dittatura militare, per chiedere il loro aiuto a rimettere in piedi il libero mercato demolito dai governi precedenti.
Risale a quel periodo anche la visita di Milton Friedman a Santiago, per un giro di conferenze di cinque giorni nel marzo del 1975, che gli è valsa l’accusa di collaborazionismo con il regime di Pinochet. In effetti Friedman in quei giorni fece un discorso intitolato «La fragilità della libertà» all’Università cattolica di Santiago, che infiammò gli animi dell’opposizione per i suoi toni antiautoritari. Nel suo discorso Friedman mise in guardia l’uditorio sulla fragilità della libertà, che viene rapidamente distrutta da ogni tipo di controllo centrale, spiegando che la libertà di espressione politica è il presupposto centrale per il corretto funzionamento di ogni libero mercato. Proprio per questa ragione il padre della scuola neoliberista americana considera a tutt’oggi stupefacente la scelta di Pinochet di affidare ai suoi allievi la gestione dell’economia cilena: «La struttura militare», così Friedman spiega la sua meraviglia, «si distingue per essere una tipica organizzazione top-down: il generale ordina al colonnello, il colonnello ordina al capitano e così via. Il mercato, invece, è una tipica organizzazione bottom-up. Il cliente entra nel negozio e ordina al dettagliante, il dettagliante invia l’ordine su per la catena fino al produttore e così via. I principi di base dei militari, dunque, sono esattamente il contrario della struttura organizzativa del libero mercato o di una società democratica. È stupefacente che per gestire l’economia i militari cileni abbiano adottato la struttura bottom-up invece della struttura top-down usata fino ad allora».
Pinochet, saggiamente, distingue l’ambito militare da quello economico, e lascia mano libera ai Chicago Boys, tranne su qualche particolare come la privatizzazione delle miniere di rame, cui mette il veto. José Pinera si occupa della privatizzazione del sistema pensionistico, Hernan Buchi di quella del sistema sanitario, Sergio De Castro e Carlos Caceres si alternano al vertice del ministero delle Finanze, Luis Larrain è ministro per la Pianificazione, Patricia Matte per lo Sviluppo, Pablo Ihnen, Carlos Mendez e Martin Costaba gestiscono il bilancio dello Stato, per non citare che i nomi più importanti. La terapia shock comprende la liberalizzazione dei prezzi e del commercio, la privatizzazione del sistema pensionistico e sanitario, l’abbattimento dei dazi e delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali e una robusta politica anti-inflazionistica. Di conseguenza esplodono le esportazioni di frutta, vino, prodotti ittici e legname, che diventano gradualmente più importanti del rame, e comincia a svilupparsi un’industria alimentare molto competitiva.
L’effetto è il cosiddetto «miracolo cileno», con una rapida discesa dell’inflazione e una fortissima espansione economica. Ma con il varo della nuova Costituzione, che designa Pinochet al potere per altri otto anni, aumenta l’isolamento internazionale del regime. Il peso del debito, indotto contingentemente dal massiccio afflusso di petrodollari dai Paesi arabi in tutto il Sud America dopo gli anni del boom del prezzo del petrolio, porta al fallimento a catena di molte economie sudamericane, a partire dal Messico.
L’improvviso crollo degli investimenti esteri spinge anche il Cile al collasso nel 1982: dopo sei anni di tassi di crescita stratosferici, il prodotto interno lordo cileno perde di colpo il 14 per cento, la disoccupazione schizza al 33 per cento. Ma Pinochet mantiene la barra sulla rotta neoliberista, e una decisa svalutazione del peso ridà fiato alle esportazioni, rimettendo in equilibrio la barca già l’anno seguente, mentre il resto dell’America Latina continua a risentire di quella crisi per tutto il decennio (chiamato appunto il «decennio perduto»).
In complesso, sotto la guida dei Chicago Boys l’economia cilena è cresciuta molto più rapidamente dei suoi vicini, a un ritmo del 5-6 per cento all’anno. Ma l’eredità più importante di tutta l’operazione resta il radicale cambiamento di direzione rispetto alle politiche del passato, che ha preparato il Cile molto meglio dei suoi vicini alla successiva ondata globalizzatrice.
Coscienti di questo vantaggio competitivo, anche i tre presidenti democratici che si sono succeduti dopo il plebiscito del 1988 hanno mantenuto l’apertura al libero mercato e alla concorrenza internazionale come caratteristica fondamentale delle loro politiche economiche, proseguendo nella scia tracciata ai tempi di Pinochet. Al momento attuale il Cile è indubbiamente l’economia più stabile del Sud America e in anni recenti il suo modello è stato adottato con alterni successi più o meno dappertutto.
Per i Chicago Boys, riciclati in gran parte come consulenti dei vari governi dell’America Latina attraverso l’Istituto per la libertà e lo sviluppo, anche oggi il lavoro non manca.



Tornano i Chicago Boys
di Redazione
Con la sconfitta elettorale del centro-sinistra e l'avvento alla presidenza dell'imprenditore Sebastián Piñera (che s'insedierà a marzo), quello che in Cile si va profilando è il ritorno in forza, alla guida dell'economia, di alcuni di quegli studiosi liberali, detti «Chicago Boys», che già ebbero un ruolo rilevante ai tempi del regime del generale Augusto Pinochet. Ovviamente una simile notizia sta gettando nello sconforto alcuni commentatori europei, ma solo perche in troppi casi mancano informazioni fondamentali.
In particolare, se vista da qui la nomina di Cristián Larroulet a capo dello staff economico di governo può sorprendere (perchè egli fu uno dei consiglieri economici di Pinochet), a Santiago la percezione è alquanto diversa. E non solo perchè il governo includerà vari indipendenti e perfino qualche ex-ministro, come Jaime Ravinet, esponente della Democrazia cristiana e ora designato ministro della Difesa. Ma i cileni non sono affatto scandalizzati soprattutto perchè essi sanno che la loro vicenda storica fu assai più complicata di quanto non si pensi.
Al tempo di Salvator Allende, entro lo scontro bipolare che opponeva Stati Uniti e Unione Sovietica il Paese stava per scivolare verso logiche collettiviste, e se questo certo non giustifica certe azioni che furono poi commesse dalla giunta militare, pure ci obbliga a leggere quei fatti in termini realistici.
Nello specifico, il ruolo svolto dai «Chicago Boys» di Milton Friedman fu fondamentalmente positivo. Tutto prese il via con la sottoscrizione, a partire dagli anni Cinquanta, di un accordo di cooperazione tra l'istituto di economia dell'università di Chicago e l'università Cattolica del Cile, una cooperazione che favorì il formarsi di un gruppo di studiosi tesi a valorizzare la proprietà, il mercato, la concorrenza. Quando il regime di Pinochet s'impose, ad alcuni di questi economisti fu chiesto di offrire un proprio contributo al salvataggio dell'economia del Paese: e ci fu chi accettò di buon grado.
Uno di questi fu Josè Piñer, a cui tra le altre cose si deve quella riforma delle pensioni che ha introdotto un sistema a capitalizzazione, il quale ha svolto e continua a svolgere un ruolo cruciale nel consolidamento dell'economia di questo Paese.
Se oggi il Cile è un'eccezione all'interno del desolante panorama dell'America meridionale ed è un sistema pluralistico consolidato e stabile, molto si deve alle riforme economiche introdotte dagli studiosi liberali e al fatto che il Cile è una delle economie più liberalizzate al mondo. Nell'indice delle libertà economiche della Heritage Foundation, ad esempio, il Cile si trova al decimo posto, nonostante i governi progressisti degli ultimi anni abbiano fatto perdere qualche posizione. È grazie alla sua struttura istituzionale leggera (limitata tassazione e minima regolamentazione) che oggi il reddito pro-capite cileno è comunque intorno ai 15mila dollari, contro i 4mila della Bolivia o i 10mila dello stesso Brasile.
Va anche detto che i «Chicago Boys» non sono scomparsi dalla scena con l'avvento della democrazia. Al contrario, hanno continuato la battaglia nel campo delle idee. Dal 1990 lo stesso Larroulet è direttore di Libertad y Desarrollo, think-tank che ha compiuto un grande lavoro di promozione delle idee liberiste. Di recente lo stesso economista ha sottolineato, richiamandosi a Friedrich von Hayek, «che l'unico modo per cambiare il corso della società consiste nel mutarne le idee. Il Cile è una buona dimostrazione di tutto ciò».
Pinochet e la Chiesa Cattolica
Augusto Pinochet è sempre stato profondamente cattolico, tanto che, nel 1986, preso di mira da una sparatoria, attribuì alla Madonna lo scampato pericolo: e la prova era il profilo della Vergine disegnato dalle pallottole sulla sua Mercedes corazzata.
Negli ultimi 30 anni il suo confessore è stato un sacerdote italiano, padre Luciano Bosia, genovese, dell'ordine dei Figli di Santa Maria Immacolata, che vive in Cile dal 1970. Un legame molto sentito, un forte rispetto reciproco, tanto che Pinochet lo volle come cappellano militare dell'esercito, nonostante la sua nazionalità non fosse quella cilena.
Si sono conosciuti a Santiago, qualche anno dopo la presa del potere da parte del generale, quando il sacerdote aveva preso possesso della parrocchia del quartiere in cui viveva Pinochet. «Ogni domenica veniva in alta uniforme alla Messa, con la moglie e i figli - racconta padre Bosia -. Aveva un alto senso della fede e un grande senso dello Stato». Pinochet seguiva spesso la Santa Messa indossando degli occhiali scuri (presumibilmente per non rimanere abbagliato dallo splendore dell'Ostia divina...).

Gli ultimi pensieri del generale, padre Luciano Bosia li porterà sempre chiusi nel suo cuore, un mistero custodito nel segreto della confessione: «Pinochet ha mantenuto la sua fermezza fino all'ultimo, crede di aver sempre fatto tutto con estremo senso di responsabilità. I suoi ultimi pensieri, fuori dalla confessione, li ha rivolti alla moglie e ai suoi figli, come farebbe qualsiasi persona a questo mondo ispirata dal senso cristiano della vita».
Ma padre Bosia conosceva Pinochet da tanti anni e non ha remore a svelare quello che era stato il grande cruccio del generale dopo la sua caduta: «Ha fatto un grande errore, quello di non indire elezioni democratiche dopo i primi anni di governo - spiega -. Lui di questo era conscio, sapeva che aveva sbagliato, perché nei primi anni del suo governo il 90% dei cileni era con lui: è stato dominato dalla passione politica».
Il governo di Allende, la protesta del popolo contro le nazionalizzazioni, gli scioperi generali e la minaccia sovietica sul Cile, quegli anni difficili sono nella mente di chi ha seguito la vicenda da vicino, ma con gli occhi di un osservatore esterno: «Furono anni delicati, racconta padre Luciano, l'intervento di Pinochet fu molto duro, ma salvò il Paese da una guerra civile che era ormai alle porte. Il Cile stava rischiando di diventare un paese comunista sotto il controllo della Russia. La scelta di intervento fatta dai generali dell'esercito direi che fu necessaria, anzi auspicata dal popolo».
La morte di Augusto Pinochet e quello che sta succedendo a Santiago e in tutto il Paese, secondo il prete italiano, vengono raccontate in Europa in maniera molto distorta: «In Italia e nel resto del continente, arrivano immagini e commenti sbagliati di quello che sta accadendo in Cile: centinaia di migliaia di persone stanno portando il loro ultimo saluto al generale, ma lì da voi si dà più spazio ad un migliaio di persone che in nome del comunismo festeggiano bevendo birra per la morte di un uomo».
Padre Bosia è rimasto legato al generale fino agli ultimi giorni della sua vita, gli ha fatto ogni giorno visita in ospedale, lo ha confessato e gli ha dato l'unzione degli infermi: «Sono stato a trovarlo in ospedale, accompagnato dalla moglie Lucia - spiega padre Luciano -, l'ho accompagnato spiritualmente alla fine della sua vita terrena: era molto sofferente, ma ha avuto la forza di tenermi la mano, di parlarmi e mi ha chiesto di benedirlo. L'ho benedetto perché ha salvato il Cile dalla guerra civile e ha amato la sua terra».
Ed è così che Augusto Pinochet, cattolico, in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, munito dei sacramenti di Santa Madre Chiesa, è potuto andare fiduciosamente, a braccia aperte, incontro a Dio.

E' bene ricordare che il 18 febbraio 1993, la privatissima ricorrenza delle nozze d'oro di Pinochet venne allietata da due lettere autografe in spagnolo che esprimevano amicizia e stima e portavano in calce le firme di Papa Wojtyla e del segretario di Stato Angelo Sodano.
«Al generale Augusto Pinochet Ugarte e alla sua distinta sposa, Signora Lucia Hiriarde Pinochet, in occasione delle loro nozze d'oro matrimoniali e come pegno di abbondanti grazie divine», scriveva il Sommo Pontefice, «con grande piacere impartisco, così come ai loro figli e nipoti, una benedizione apostolica speciale. Giovanni Paolo II.»
Ancor più caloroso e prodigo di apprezzamenti fu il messaggio di Sodano, che era stato nunzio apostolico in Cile dal '77 all'88, e che nell'87 aveva perorato e organizzato la visita del papa a Santiago, ponendo giustamente in non cale le querule proteste di certi circoli cattolici impregnati del succo della mala pianta conosciuta come "teologia della liberazione" (rectius, teologia della schiavizzazione comunistica....).
Il cardinale scrisse di avere ricevuto dal pontefice «il compito di far pervenire a Sua Eccellenza e alla sua distinta sposa l'autografo pontificio qui accluso, come espressione di particolare benevolenza». Aggiunse: «Sua Santità conserva il commosso ricordo del suo incontro con i membri della sua famiglia in occasione della sua straordinaria visita pastorale in Cile». E concluse, riaffermando al signor Generale, «l'espressione della mia più alta e distinta considerazione». Dichiarazioni, quelle di Sodano e del papa, tanto più rilevanti e significative, perché a quell'epoca Pinochet non era più Capo dello Stato.
La straordinaria visita pastorale del papa in Cile del 1986 aveva avvicinato due uomini meritatamente entrati nella storia anche per avere entrambi combattuto e sconfitto, stringendolo come in una morsa, il cancro del comunismo

da sempre definito dal Magistero della Chiesa come "intrinsecamente perverso", e bollato dal cardinale Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, felicemente regnante, come "la vergogna del nostro secolo".
Il Papa, tra l'altro, disse che Pinochet era un cristiano esemplare, che la sua era una famiglia modello, che la sua lotta contro il comunismo era un servizio alla Chiesa, e che la sua insurrezione contro il governo Allende era stata necessaria per ristabilire un ordine sociale cristiano.
Nel corso di una Messa, caratterizzata da una fortissima tensione mistica, fu il Papa stesso a porgere la Santa Comunione a Pinochet. I due illustri personaggi si affacciarono poi insieme, scatenando l' entusiasmo delle masse cilene (e scatenando pure una canea di proteste nei soliti ambientini anticattolici e pseudocattolici) dal palazzo della Moneda

quello stesso palazzo nel quale Salvador Allende scelse sciaguratamente di disporre in modo dissennato della propria vita.

[Tra l’altro, la sinistra cilena e internazionale aveva negato per anni che Allende si fosse suicidato, sostenendo invece che era stato ucciso per volontà di Pinochet. Ma lo scorso anno una autopsia ufficiale ha confermato senza ombra di dubbio che il leader marxista si è suicidato…]
Il mese scorso il cardinale Francisco Javier Errazuriz, vescovo di Santiago, e primate del Cile, appena saputo del ricovero di Pinochet, si era recato a visitarlo. Al termine della visita aveva esortato i cileni a pregare per Pinochet, e si era recato lui stesso nella chiesa castrense di Santiago, per celebrare una Messa di intercessione.
Sopravvenuta la morte, nella camera ardente in cui il corpo di Pinochet è rimasto un giorno e mezzo sono state celebrate tre Messe solenni, una delle quali dal cardinale Errazuriz, vestito con i colori della bandiera - veste bianca, stola blu, cappello rosso. Nel corso della Messa funebre il cardinale Errazuriz ha così concluso la sua omelia: "In questa ora ringraziamo per tutte le qualità che Dio gli diede, e per tutto il bene che lui ha fatto alla nostra patria e alla sua propria istituzione. Chiediamo a Dio che gli perdoni i peccati e le omissioni. Che tenga conto di tutto il bene che lui ha fatto e che lo accolga in pace e amore. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen".


-
06-03-12, 23:11 #6Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
I libanesi maroniti sono un popolo straordinario: cristiani cattolici,
sono riusciti a mantenere la loro fede e la loro indipendenza per secoli,
nonostante fossero da soli, circondati da un oceano musulmano.
Riporto alcuni brani del libro di Nathalie Duplan e Valerie Raulin:
Il Cedro e la Croce-Jocelyne Khoueiry, una donna in prima linea
Edizioni Marietti 1820.
Nell'aprile 1975, in Libano scoppia la guerra. Jocelyne Khoueiry, che
allora aveva appena vent'anni, imbraccia il fucile per difendere il suo paese
minacciato dai palestinesi islamici che hanno instaurato uno Stato nello Stato
libanese.
Fa parte dei fautori della Falange cattolica di Bachir Gemayel e combatte,
contro i reparti scelti, e a fianco delle truppe d'assalto, nei violenti
scontri che devastano il centro della città di Beirut, prima di fondare
una sezione femminile che comprenderà più di un migliaio di soldatesse.
Si guadagna il rispetto e poi l'ammirazione dei suoi camerati guidando
le milizie femminili da lei stessa addestrate.
La notte del 6 maggio 1975, da sola con sei "ragazzine", ancora
più giovani di lei, che all'epoca aveva venti anni, riporta una vittoria
decisiva contro trecento nemici armati di tutto punto.
Nasce così la leggenda di "Jocelyne e le sue ragazze".
In seguito affiancherà alla lotta militare la promozione e l'approfondimento
della fede cattolica tra le truppe libanesi.
Per dieci anni, fino al 1985, si troverà su tutti i fronti per incitare
alla lotta e alla speranza nel cuore del conflitto. Negli anni successivi,
al fine di portare il suo aiuto ai bambini, alle famiglie e ai bisognosi,
ha fondato il Centro Giovanni Paolo II, nelle vicinanze di Beirut.
È inoltre diventata membro dell'Accademia mariana pontificia
internazionale e rappresentante dei laici del Medio-Oriente in Vaticano.
Attraverso il ritratto di questa donna fuori dal comune, si ricostruisce
un tratto della storia dolorosa e complessa del Libano cristiano, che prelude
ai tragici fatti della cronaca odierna.
"A differenza di paesi come la Siria e la Giordania, il Libano aveva
accolto, dal 1948, 150.000 rifugiati palestinesi costretti a un vero
e proprio esodo a causa della creazione del nuovo Stato di Israele.
Il patriaca maronita Antoine Arida aveva lanciato un appello ai suoi fedeli:
"Tutti voi avete il compito, di fronte a questa calamità, di aprire
le vostre case e i vostri conventi per accogliere le vittime della sorte,
i nostri fratelli palestinesi...."
Il fragile equilibrio comunitario del paese aveva cominciato a vacillare,
dato che il novanta per cento dei palestinesi era musulmano. Ma i libanesi
avevano continuato a permettere che essi si installassero presso di loro.
Negli anni Settanta erano quasi quattrocentomila, su una popolazione
libanese inferiore ai tre milioni di abitanti! L'attivismo crescente
degli uomini di Yasser Arafat seminava sempre più disordini....".
"Sono le nove di sera, la notte è ormai scesa. Jocelyne aveva avvertito
i suoi genitori che sarebbe rientrata tardi....
Un musulmano, identificabile dall'accento come abitante di Beirut ovest,
la fulmina: "Signorina, il paese che amate tanto sarà presto nostro,
e i cedri verdi diventeranno rossi di sangue".
Lei gli risponde: "Mai. Dovrete prima passare sui nostri cadaveri:
solo così vi impadronirete della nostra terra".
Per la strada, dirigendosi verso casa, scoppia a piangere.
Di rabbia, di dolore, di impotenza."
"A capo dell'inquadramento delle reclute c'è Francis de Borella,
un ufficiale francese della Legione Straniera. E' venuto qui perchè si sente
doppiamente coinvolto nel conflitto. Non solo considera il Libano come
un paese amico nei cui confronti ha una responsabilità, ma anche perchè,
essendo cristiano, non sopporta l'idea che si cerchino di sopprimere
suoi correligionari.
Jocelyne corre a perdifiato, imparando a respirare, arrampicandosi
su ostacoli prefabbricati, valicando burroni naturali, aprendosi un varco
tra la vegetazione spesso irta di spine, scalando i muretti delle terrazze.
Il sole scotta, i suoi piedi anche, il suo cuore batte forte, lei gronda
di sudore.
"Correte, correte - ordina de Borella - guardate, è una ragazza quella
che corre più veloce di voi!" Francis l'ha assegnata alla testa del battaglione
dei giovani. Non può stramazzare, non può fermarsi. Vuole, deve continuare.
Fra poco Francis si complimenterà con lei.
Le sue parole riecheggiano dentro di lei come quelle
di un fratello maggiore quarantenne, quale lui gli appare.
Jocelyne le sente ancora oggi."
"Tra una incursione e l'altra, Francis de Borella la inizia al combattimento
nelle strade; le insegna a guardarsi a destra, a sinistra, a forzare
una porta, a prestare attenzione ai terreni o ai corpi che potrebbero
essere imbottiti di esplosivo, alle imboscate; a riuscire a spostarsi
velocemente, tenendo sempre viva l'attenzione.
Anche se il suo compito la esalta, a volte ha paura.
In seguito all'ultimo di questi pattugliamenti, Francis
ha l'aria di essere compiaciuto della sua allieva.
Sorride: "Brava, la mia piccola guerrigliera".
"Quel mattino Francis porta altre ragazze, tra cui Pierrette e Dolly,
nel centro della città. Si sono installati sul tetto del cinema Capitole.
I palestinesi, invece, si sono impossessati dell'edificio vicino
al lazzaretto, di fronte alla chiesa maronita di Saint-Georges.
Improvvisamente, si sente una detonazione.
Un foro scuro in mezzo alla fronte, un corpo che si tende, rimane
immobile per un istante, poi crolla all'indietro: Francis è morto.
E' il primo di una lunga serie di caduti. Una serie talmente numerosa
che, ancora trent'anni dopo, quando una persona arriva a casa con aria
preoccupata, o il telefono suona all'improvviso, Jocelyne non può evitare
di immaginarsi il peggio. Le occorre tutta la fede che ha per non lasciarsi
sopraffare dalle lacrime e da quella angoscia diffusa che la attanaglia
quando pensa alle persone che ama, alle loro sofferenze, o alla loro
scomparsa. Francis fa parte di quei morti che la hanno toccata sul vivo."
"In luglio e agosto arrivano decine di ragazze.
Perchè Jocelyne ha deciso di selezionarle?
Perchè ha ravvisato in loro alcune qualità. Sono "brave" (vale a dire
coraggiose) agili, rapide, abili. Sono intelligenti e sono in grado
di capire il senso della lotta da condurre. Si tratta di difendere il paese,
di affermare la sua specificità e il suo diritto ad esistere. Di comprendere
che i suoi valori sono in pericolo, e che bisogna proteggerli affinchè
durino nel tempo."
"Chi è là?" urla uno dei ragazzi.
"Josso".
"Sei capace di usare un RPG B7?" [Un'arma anti-carro]
Non lo ha mai fatto, ma l'idea la assilla dal tempo del campo
di addestramento. Quell'arma lancia dei razzi dotati di una grossa carica
di polvere da sparo. Quando la si usa, bisogna che non ci sia nessuno intorno
per un raggio di chilometri: sarebbe pericoloso a causa dello spostamento
d'aria dovuto all'esplosione.
Un giovane di diciassette anni le spiega: "C'è un carro armato proprio
qui davanti, che spara continuamente, ma nessuno di noi sa maneggiare
questo arnese."
Jocelyne si mette dietro di loro, accucciata, con il RGP sulla spalla.
Si sono messi d'accordo. Mitraglieranno il carro armato per coprirla,
lei si alzerà e sparerà.
La ragazza segue le istruzioni, e il veicolo esplode.
I ragazzi si congratulano con lei, che poi riparte per il suo caseggiato."
"Quel mattino, Jocelyne si reca sulla barricata di Nazo.
"A che punto siamo con il nostro carro armato?"
"E' andato avanti, ma il ragazzo sulla torretta non riesce a sparare".
Infatti, il poveretto spunta di tanto in tanto dalla torretta, cercando
di seguire le indicazioni del pilota e del radiofonista.
Ma appena tira su la testa, gli sparano addosso.
Dopo una mezz'oretta, la ragazza chiede a Nazo: "Lascia che salga io
sul carro armato".
Nazo e i suoi uomini la guardano, sbalorditi e senza grande entusiasmo:
"Dici sul serio?"
"Sì"
E Jocelyne si precipita. Il carro armato avanza di nuovo. Una volta
raggiunto il centro della strada, esce dalla torretta e colpisce in pieno
il bersaglio.
Dietro la loro barricata, le ragazze applaudono. Nazo è stupefatto.
Tra di loro non c'è ombra di rivalità quando si tratta di mostrare
chi è il migliore."
"Cala il buio, con le sue angosce.
Nei vicoli, alcuni soldati urlano il suo nome: "Prima o poi ti faremo
la pelle, a te e alle tue amiche", grida uno di loro.
Di colpo, si sente invasa da una sensazione strana. Una brezza leggera,
viva, la attraversa dalla testa ai piedi. In lontananza sente come degli
inni, dei rulli di tamburo indefinibili. E poi una "Presenza" straordinaria
la spinge a inginocchiarsi.
Tende le braccia verso il cielo e prega, fiduciosa.
Implora la Vergine Maria: "Proteggete le ragazze: fate che io non debba
mai recarmi dai loro genitori per annunciare che sono morte".
"Sono le ventidue: è l'inizio dell'attacco, talmente assordante da spaccare
i timpani. Jocelyne si precipita sulle scale con le altre. Marcelle viene
colpita a una gamba. La piccola Nina -ha soltanto quattordici anni-
le ha appena raggiunte e chiede informazioni al suo capo.
Jocelyne grida:
"Volete resistere? Combattere? Fino alla morte, se è il caso?"
In coro, le ragazze rispondono: "Sì!"
Jocelyne, inconsapevolmente profetica, aggiunge:
"Un giorno la storia parlerà di voi."
Malgrado la ferita, Marcelle va avanti.
L'azione si svolge molto rapidamente.
"Nina, tu resti dentro a ricaricare le armi; Marcelle e Brigitte,
tornate ai vostri posti; Dolly e Laura, correte su place de le Martyrs.
Tu, Marie-Rose, al terzo piano con il Bren."
Ognuna raggiunge la sua postazione.
Marcelle trascinando la gamba in modo preoccupante.
In strada, un tizio dà un ordine che riguarda proprio loro:
"Scaricategli addosso l'artiglieria! Fuoco!"
La Raissè [femminile di Raìs: Capo, Duce, denominazione che Jocelyne
si era guadagnata sul campo] si precipita al piano del RPG. Niente da fare:
le cartucce sono umide, e l'arma non funziona. Nel buio, attraverso
la feritoia, intuisce un nemico numeroso. Gli avversari si sgolano,
altri gridano il suo nome, accompagnato da epiteti fantasiosi quanto
poco delicati.
Dalla sua postazione, avvista un carro armato che si avvicina al caseggiato.
Al primo piano Jocelyne tenta di sparare un razzo anticarro, a vuoto:
non è neanche partito.
Un giovane del Regent, dove si trovava Nazo poco tempo prima, sotto
una pioggia di proiettili, schegge di pietra, esplosioni, esclama:
"Prendi la mia arma, gli altri si sono ritirati, io me ne vado."
Si è già dileguato.
Adesso le ragazze non sono più protette da dietro, sul lato
di place de Martyrs.
Ogni cosa si svolge ora molto velocemente, con esito pessimo:
centinaia di palestinesi le hanno accerchiate e separate dai rinforzi.
Il loro immobile è isolato.
Jocelyne non ci crede più, ma non lascia trapelare nulla. Sotto la sua
spinta e i suoi ordini, le sei ragazze continuano il combattimento.
Tutto sembra perduto, ma Jocelyne arrischia un'ultima manovra: risale
sulla terrazza, stando bene attenta a non farsi individuare. Saltando
da un tetto di edificio all'altro - sono tutti contigui - riesce ad aggirare
i nemici.
Cerca di trattenere il respiro, che si è fatto affannoso, e di calmare
il cuore che si sente in gola.
Prende il respiro per l'ultima volta, lancia le sue granate con tutta
la forza che ha, si abbassa, per poi rialzarsi immediatamente,
e vuotare il caricatore del mitra.
Di sotto, il panico si fa sentire: il loro capo è stato ucciso e i soldati
si ritirano, gridando. In un immenso scompiglio.
Quella notte Jocelyne e le sue ragazze acquistano grande prestigio, anche
perchè i ragazzi, che non potevano più tenere le barricate, le avevano
abbandonate. Quel mini-esercito femminile ha appena riportato
una vittoria storica."
"Un pò di tempo dopo, Jocelyne entra nella chiesa.
E' vuota, c'è solo la statua della Vergine.
Si dirige verso di lei, si genuflette piegando prima un ginocchio,
e poi l'altro. E in questo luogo le fa dono della propria vita, le offre
la divisa militare a cui tiene tanto. Le chiede di accettarla come soldato
del Suo esercito. Pronuncia una sorta di atto di consacrazione.
In privato.
A tu per tu con Maria, sua Madre, che le ha protette nella notte
del 6 maggio, che le ha portate alla vittoria."
"Il più bell'incontro che abbia fatto è quello del Carmelo.
Lassù, sulla montagna di Harissa, che domina la baia di Juniah, in mezzo
ai pini che scendono a precipizio ai piedi di Notre-Dame du Liban...
Quel pomeriggio d'autunno i cancelli del Carmelo ricevono la sua
testimonianza. Poi le sorelle le svelano un segreto che spiega molte cose.
"Se tu sapessi, Jocelyne" le confida Madre Therese, la superiora, "quanto
abbiamo pregato per te quando eri sulle barricate, affinchè il Signore
ti accogliesse tra le Sue Braccia!"
Nonostante tutto, rimane un enigma: quale è dunque il disegno
che Dio ha riservato a lei?"
"Non ha più tempo per riflettere: l'ufficio di Bachir è davanti a lei;
lei è di fronte a lui, senza la sua divisa militare.
Lo sguardo di Bachir si posa sulla sua gonna, poi sulle scarpe.
Indugia su esse e sorride.
La squadra di nuovo.
Vede bene che non è più la stessa.
"Sai, Jocelyne, le ragazze del Libano sono diventate menefreghiste,
immorali. Conducono una vita disordinata. Se sei d'accordo di assumere
la direzione delle militanti [della Falange libanese] potrai forse
trasmettergli il senso delle responsabilità, inculcare loro dei valori".
Parlando in tale modo, Bachir la sorprende, la disorienta.
La Raissè si immagina ora sui campi di battaglia, a distribuire
copie del Vangelo.
Le viene un'intuizione: "Quello che puoi fare vestita della divisa,
non potrai realizzarlo in un convento".
Era venuta per rifiutare, educatamente, l'offerta di Bachir.
Invece la accetta, entusiasta".
"La cosa più sorprendente è il suo ardore.
Si precipita a casa. Fruga nei bauli.
Da essi escono, - come un tesoro dalla caverna di Alì Babà - i suoi abiti
militari, appena ricoperti di polvere. Jocelyne li ispeziona, li contempla,
stupita della loro inaspettata attrattiva.
Si dice che l'abito non faccia il monaco: non basta neanche
a fare il soldato.
Deve rimettersi al lavoro e il tempo stringe. Tanto più che la milizia
di ieri si è trasformata in un vero e proprio esercito....
C'è un presente. E addirittura una urgenza: la ripresa dell'addestramento
militare interrotto per un anno e mezzo. Jocelyne deve riguadagnare
la sua agilità fisica, recuperare la sua resistenza.
E poi c'è il reclutamento: deve scegliere delle ragazze per rimpinguare
i ranghi."
"Corsi di resistenza, maneggiamento delle armi, scoperta dell'artiglieria,
logistica, tornano a scandire le giornate. Le centinaia di ragazze non
dissimulano il loro entusiasmo di cominciare quel tipo di routine.
Ma neppure nascondono il loro stupore quando la Raissè comunica loro
il programma della serata: "Come? Una veglia evangelica?"
Per quella prima veglia, tutto è improvvisato.
Le ragazze si dispongono intorno a Jocelyne.
Quest'ultima apre il Vangelo - è il Prologo di san Giovanni -
e legge il testo.
I visi si animano, le espressioni cambiano.
Da ogni sguardo traspare il loro ardore, come negli occhi luminosi
di Souraya, orlati di ciglia brune e spesse che non finiscono mai
di distendersi verso il cielo. Ha appena diciott'anni, una baby face
molto espressiva sulla quale sembra indugiare un sorriso che
le conferisce un'aria di scherno vagamente insolente.
Ma in quel momento essa svanisce, e le lacrime che stillano
dai suoi occhi non sono finte...."
"Quel primo campo del 1980 termina con un evento inusitato, ma che
farà epoca. Sotto il sole ancora caldo di settembre, montano la tenda
che servirà loro da mensa.
Stendono una grande tovaglia bianca su un tavolo dalle gambe
incrostate di polvere, come i loro anfibi.
Un crocefisso, una candela, una immagine della Vergine, e assistono
alla prima Messa celebrata in una cornice militare.
Un anziano sacerdote di un villaggio vicino si è prestato
volentieri a celebrarla.
Per molte di queste donne, quella è la Messa più bella, la più commovente
alla quale abbiano mai partecipato. Ognuna prega in raccoglimento
inconsueto. E' la Messa di commiato delle militanti. Quell'afflato
infiammerà la loro resistenza per tutto il tempo a venire."
"Durante le discussioni, la Raissè si accalora spesso: "Stiamo difendendo
i cristiani del Libano, ma siamo sicuri di comportarci da veri cristiani?"
Le sue domande trovano un'eco presso i combattenti. A loro piace ascoltarla
raccontare come lei e le sue ragazze hanno scoperto Dio, come ciò
ha cambiato la loro vita e conferito un rilievo particolare alla loro missione
nelle Forze libanesi. L'interesse è tale che tutte le regioni, le caserme,
le chiedono di tenere delle conferenze.
Lei continua a ribadire: "Non c'è nulla per cui vale la pena di perdere
la vita, tranne un'altra vita: la Vita con la V maiuscola".
"Tutti noi amiamo il Libano, ma quale è il Libano che vogliamo?
Di quale Libano siamo fieri?
Del Libano del commercio?
Del turismo?
E' questo il Libano che merita le migliaia di martiri che cadono
ogni giorno?
Siamo diventati talmente commerciali che siamo disposti a svenderlo
a qualunque prezzo".
"Che spettacolo diamo della nostra cristianità ai musulmani?
La nostra immoralità, la nostra avidità di denaro?
Da quando è scoppiata la guerra, vedono che ci difendiamo.
Ne abbiamo tutte le ragioni: è molto importante.
Ma il Signore ci ha messi qui per trasmettere un'altra verità,
per testimoniare.
E' grave pretendere di difendere la cristianità in Libano senza praticarne
le virtù e i valori, perchè allora siamo come i mercanti che il Signore
ha cacciato dal Tempio. E' molto grave!"
Quando si ferma, sono tutti sotto shock. E' lei per prima a capire
la portata delle parole che ha pronunciato. La cosa più curiosa
è che esse spronano inaspettatamente numerosi giovani.
Lo stesso vale per i religiosi. Al principio di questo 1981
alcuni monaci, fasciati nella loro veste nera, vengono a dirle:
"Vogliamo darti il nostro sostegno".
E una donna che aderisce a un ordine contemplativo le dice:
"Hai risvegliato in me qualcosa che era morto. Voglio aiutarti
a qualunque costo".
Nel giro di un anno, sarano una trentina le persone che avranno
mantenuto la parola, e che seguiranno le militanti, aprendo
dei cappellanati in tutte le caserme."
"Fouad Aboud Nader, allora capo di Stato maggiore, le chiede
di sottoporgli il suo piano d'azione per i mesi seguenti.
Lei gliene consegna uno modesto, che corrisponde alle loro capacità.
Nader è palesemente insoddisfatto:
"Ascolta, Jocelyne, non puoi consacrare tutto il tuo tempo e le tue energie
a questo. Non siamo in convento.... A mio avviso, dovresti sostituire
il Vangelo con un corso di educazione sessuale, affinchè le ragazze
non abbiano dei problemi nell'ambito delle Forze libanesi".
In quel preciso istante la Raissè rimane di stucco. Il sangue blu che
le scorre nelle vene smette di affluirle al cervello. Ha un'unica reazione:
afferra le carte che ha davanti a sè. Furente, le stropiccia, le schiaccia,
le spreme fino a farne stillare le parole che vi sono annotate, e gliele
sventola sotto il naso.
Dopodichè spara un'ultima bordata:
"Non avrò l'onore di lavorare con lei! Non ha la più pallida idea
di quale sia il Libano che vuole! Peccato!"
Ed esce battendo la porta....
Alcuni giorni dopo scoppia la guerra di Zalah, minando la possibilità
di ogni futura discussione, e trasferendola su un altro piano: la caserma
di Ouyoun el-Siman. E' un luogo strategico: da essa dipende il fronte che
protegge tutta la zona del Kesrouan, ossia le alte montagne della catena
del monte Libano.
Assad Said, responsabile della pianificazione delle operazioni militari,
chiede alla Raissè di dare una dimostrazione del valore delle militanti
in quella caserma, aggiungendo: "Noi finora abbiamo fatto pari e patta.
Spero che voi riuscirete. Se invece fallirete, sarà Fouad a vincere".
"Qualche tempo dopo, davanti alla statua della Vergine Maria -
che le ragazze avevano collocato all'ingresso della caserma- Bachir
commenterà con i suoi assistenti: "In questo punto dovete scrivere:
"Di qui è passata Jocelyne".
La formula fa riferimento alle frasi che, tempo addietro,
si scrivevano sulle barricate del centro città. Nel loro caseggiato,
per esempio, le ragazze avevano scritto: "Di qui sono passate
le truppe delle militanti".
Ed erano soltanto in sei!
Un giorno in cui non se lo aspetta, Fouad farà chiamare Jocelyn, e le dirà:
"Vi devo le mie scuse per quello che avevo detto. Avevi ragione tu.
Vi abbiamo osservato attentamente: siete state le più efficienti.
Devo ammettere che l'organismo delle militanti è uno dei migliori."
"Cominciano organizzando delle Messe: prima una volta alla settimana,
poi due. Il personale militare si dà spesso il cambio, e ci si preoccupa
che ogni soldato possa seguire la funzione, quando passa per la caserma.
Jocelyne mobilita le sue truppe. Ha con sè alcune ragazze molto belle.
Le convoca e le invia tra i soldati: "Yallah, avanti: portateli a Messa,
a confessarsi!"
Un metodo un pò ambiguo, ma molto convincente....
Quella sera di maggio, il mese di Maria tanto amato e venerato in Libano,
c'è una grande folla. I canti risuonano in tutta la caserma. Alla fine della
celebrazione, secondo la consuetudine, l'Abouna presenta ai fedeli una icona
della Vergine. Le volute di incenso accarezzano l'immagine, mentre viene
intonato il tradizionale "O Madre di Dio, o dolce Madre", così confortante
in un'epoca tanto difficile.
Come dimenticare le confessioni, e l'abnegazione del cappellano principale,
padre Hanna Khawand, un monaco dell'ordine maronita?
Quel mercoledì padre Hanna vive un momento memorabile
del suo ruolo di pastore.
E' seduto in attesa.
In una stanza accanto, due ragazze incoraggiano un giovane ad andare
a confessarsi. Sono dieci anni che non riceve questo sacramento.
Avrebbe voglia di fare questo passo, ma tentenna. Le sue braccia
e quelle delle ragazze si alternano, fendendo l'aria nella foga di illustrare
le reciproche argomentazioni. Man mano che la discussione procede,
i gesti del ragazzo diminuiscono. Nasconde le mani nelle tasche, ve le affonda,
rinsacca leggermente la testa nelle spalle e va a inginocchiarsi davanti al prete.
L'Abouna non ha difficoltà ad avvertire il suo imbarazzo: lo capisce.
E' passato così tanto tempo.
Con quale affetto lo prende allora tra le braccia!
Gli parla, lo rassicura, scaccia i suoi timori. Poi ascolta le sue parole
e lo assolve: il giovane è in lacrime, ma pacificato e felice.
Dopo qualche minuto, riceve la comunione con il Corpo di Cristo.
La prima comunione dopo dieci anni.
E anche l'ultima.
Un'ora dopo avere raggiunto la barricata, una granata lo falcia.
La notizia raggiunge le ragazze quasi immediatamente. La loro unica
consolazione è di sapere che, subito prima, "ha ricevuto il passaporto".
Tra i combattenti ci saranno centinaia di conversioni di questo tipo:
alcuni di loro sopravviveranno, altri no.
Esse segnano l'ingresso dell'elemento spirituale nella lotta: uno spirituale
incarnato, vissuto quotidianamente, palpabile, tangibile.
Nel giro di qualche settimana la caserma è diventata il più pacifico
dei luoghi, benchè sia il più pericoloso; il più gioioso, benchè sia
il più duro; il più accogliente, benchè sia il più lontano.
Il segreto di questo mistero?
Secondo Jocelyne, la presenza di quelle giovani donne
è "abitata dalla Presenza"."
"Dal giorno del suo arrivo nel Chouf, il gruppo è sottoposto a un diluvio
di fuoco. Padre Hanna avanza curvo, con le mani giunte sul petto,
per proteggere il Santo Sacramento, che stringe contro di sè.
Il gruppetto raggiunge il primo fronte, poi gli altri sei.
Viene accolto ovunque da esplosioni di gioia e di allegria.
Stanno per visitare l'ultimo fronte.
Intorno a loro, sibili e detonazioni.
I bombardamenti imperversano, ma i militanti avanzano
impavidamente verso i giovani che li aspettano.
Non stanno nella pelle all'idea di quel ricongiungimento.
In quel putiferio, la voce di padre Hanna è appena percettibile.
Tutti pregano con grande raccoglimento. Come se il pericolo
a un tratto non esistesse più, quando in realtà li circonda da ogni lato."
"Le ragazze sfilano in parata.
Fiere.
La stanchezza e i bombardamenti della vigilia sono ormai un ricordo.
Pierre Gemayel consegna la bandiera alla Raissè.
Quante volte ha sognato quel momento!
Ma non può neanche goderselo: è già il suo turno di prendere la parola....
La fanfara tace, Jocelyne sente solo le proprie parole, che le riecheggiano
vagamente nelle orecchie.
Si volta verso Pierre Gemayel, il modello incontestato, il punto
di riferimento di tutti loro:
"Raìs, quasi quotidianamente ci si è domandati:
"Quale Libano vogliamo?"
Noi non siamo dei politici, o dei sociologi. Ma posso affermare,
in tutta modestia, che abbiamo iniziato a trovare la risposta.
Per sapere a quale Libano aspiriamo, è prima necessario precisare
quale è il libanese che desideriamo, dato che sarà proprio lui
a costruire il Libano.
E per fare ciò, bisogna cercare la libanese: la donna
che genererà e educherà quel libanese."
Jocelyne prosegue, incoraggiata dal silenzio concentrato degli ascoltatori:
"Tutte le militanti, me compresa, assumono solennemente l'impegno
di ricostruire il Libano secondo la volontà di Maria e l'insegnamento
della Chiesa."
"Di buon mattino si mettono in marcia verso Castelgandolfo,
la residenza estiva del Sommo Pontefice.
Una cinquantina di persone assistono alla funzione.
Jocelyne è molto commossa. Ascolta con fervore quell'uomo
vestito di bianco che ricorda i suoi dieci anni di pontificato.
La Messa è finita.
La Raissè aspetta.
La sagoma atletica di Giovanni Paolo II le passa davanti.
Pierrot osa rivolgersi a lui direttamente, indicando Jocelyne:
"Lei era la responsabile delle combattenti delle Forze libanesi."
Giovanni Paolo II la guarda, ma tira dritto.
Quando ha finito di salutare tutti, torna da Jocelyne.
Il Santo Padre è ormai solo per lei.
La fissa negli occhi: il suo sguardo scintilla
di interesse e di benevolenza.
"Eri una combattente?"
"Sì, Santo Padre. Ma ora la Vergine Maria ci ha chiamate a servire
in altro modo il nostro paese."
Giovanni Paolo II profetizza: "So che farete molto per il Libano."
Commossa, Jocelyne consegna al Papa il logo del movimento, e una lettera
redatta con Nawal e Arzè. Giovanni Paolo II li benedice, con un gesto
ampio e paterno."
"Un altro orizzonte si apre nel 1995, quando Jocelyne scopre l'enciclica
del Papa, "Evangelium vitae". Cogliendo l'urgenza di questo appello
in favore della vita, si circonda di specialisti - medici, ginecologi,
farmacisti – ma anche di coppie di coniugi. In tale modo nasce il movimento
"Sì alla vita", che si colloca immediatamente nell'ambito della Commissione
episcopale per la famiglia in Libano".
"Non conoscendo bene alcune realtà libanesi, il Papa aveva chiesto
nel 1980 a un vescovo con il quale stava pranzando:
"Mi può spiegare chi sono questi maroniti?"
Il vescovo gli aveva esposto un breve riassunto della loro storia.
Poi aveva aggiunto:
"Santo Padre, in Libano abbiamo un proverbio che dice:
"Noi maroniti seguiremo il Papa sino all'inferno".
Aggrottando il sopracciglio, Giovanni Paolo II aveva ribattuto:
"Pensate forse che il Papa stia all'inferno?"
"No, Santità. Noi diciamo che lo seguiremmo
anche se si recasse all'inferno."
Allora, con stupore, il Papa aveva affermato:
"Bello! Nemmeno in Polonia esiste un detto simile!"








-
12-03-12, 23:47 #7Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
Nicola di Flue, il santo patrono della Svizzera, fu al contempo
un grande soldato in senso materiale e un grande soldato
in senso spirituale.
Egli si dimostrò un cattolico esemplare in ogni ambito dell'esistenza:
da giovane combattè coraggiosamente e valorosamente per la sua Patria;
poi conquistò, a suon di jodel, il cuore della sua futura sposa, e divenne
un lavoratore e un padre di famiglia esemplare, generando dieci figli;
indi ascese alle più importanti cariche pubbliche: fu giudice, deputato
e poi consigliere del suo Cantone; infine, con il permesso di sua moglie,
intraprese la vita eremitica, e per venti anni non assunse alcun cibo,
nutrendosi esclusivamente del Pane dei Forti.

Non cessò per questo di occuparsi della sua Patria, e anzi,
nel momento in cui essa rischiava di disgregarsi a causa dei
dissensi tra i vari Cantoni, solo grazie al suo intervento, e al prestigio
di cui godeva universalmente, fu possibile stipulare il Patto di Stans,
considerato il primo Statuto costituzionale della Svizzera.
Questo patto, che regolò i rapporti tra i confederati fino alla
diabolica Rivoluzione francese, fu poi fondamentale per superare
i contrasti che nacquero ai tempi della eresia protestante.
Anche per questo san Nicola di Flue è considerato dagli svizzeri
"il Padre della Patria".
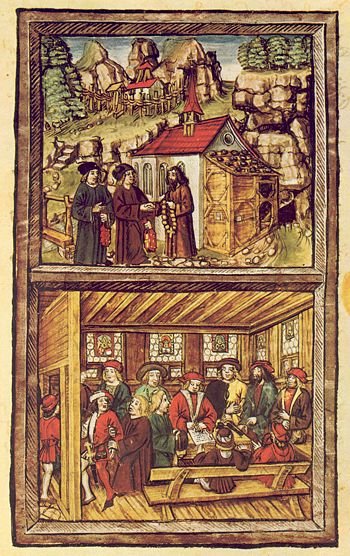
Ebbene, negli atti del processo di beatificazione, si sottolineano pure
le sue qualità di soldato, e ci si compiace di ricordare che il grande santo
era solito combattere con "la spada o l'alabarda in una mano, e il rosario
nell'altra" ("In der einen Hand den Spiess oder Hellbarten, und in der
andern aber das Bette").
San Nicola di Flue prefigurava così i grandi Conquistadores spagnoli,
che di lì a pochi anni avrebbero conquistato e cristianizzato gli imperi
meso e sud americani, con la spada in una mano, e col Vangelo nell'altra.
Così i veri cattolici oggi, dovrebbero essere sempre pronti a staccare
dal muro l'alabarda, la spada e lo stocco, al fine di combattere per la gloria
di Dio e per la grandezza della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana.





Il Salmo Svizzero è l'inno nazionale della Svizzera.
La sua storia risale al 1841, quando l'inno fu composto
dal monaco cistercense dell'abbazia di Wettingen
Alberik Zwyssig (1808-1854).

Salmo Svizzero
Testo di Camillo Valsangiacomo (1898-1978)
Quando bionda aurora il mattin c'indora
l'alma mia t'adora Re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol,
cittadino, Dio lo vuol,
cittadino, Dio, sì Dio lo vuol!
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera
Te ritrovo a sera, o Signor!
Nella notte silenziosa
l'alma mia in Te riposa:
libertà, concordia, amor,
libertà, concordia, amor,
all'Elvezia serba ognor.
all'Elvezia serba ognor.
Se di nubi un velo m'asconde il tuo cielo
pel tuo raggio anelo, Dio d'amor!
Fuga o sole quei vapori
e mi rendi i tuoi favori.
di mia patria deh! Pietà
di mia patria deh! Pietà
brilla, Sol di verità,
brilla, solo Sol di verità!
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo
m’è ostel tuo grembo, o Signor!
In te fido Onnipossente
deh, proteggi nostra gente;
Libertà, concordia, amor,
Libertà, concordia, amor,
all'Elvezia serba ognor.
all'Elvezia serba ognor.

-
24-04-12, 01:55 #8Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
Riporto alcuni articoli dedicati alla figura di Aldo Gastaldi, detto “Bisagno”, e ad altri due partigiani cattolici morti in circostanze misteriose…
La Resistenza cancellata
di Alberto Leoni
La Resistenza antifascista non fu composta soltanto da socialisti e comunisti. Ma i partigiani anticomunisti stati “cancellati”. Perché non smentissero l’egemonia della memoria storica voluta dal Partito comunista?
[Da «il Timone» n. 59, gennaio 2007]
In una recente trasmissione televisiva, dedicata all’opera La grande bugia di Giampaolo Pansa, si constatava come i nomi di Giuseppe Perotti, Ignazio Vian e Duccio Galimberti non dicessero più niente alla quasi totalità degli italiani. Tanto perché si sappia, il generale Giuseppe Perotti fu quello che, nel momento delta sua condanna a morte nel gennaio del 1945, si rivolse ai coimputati e comandò: «Signori ufficiali! Attenti! Viva l’Italia!». Ignazio Vian, tra i primi a prendere le armi contro i nazisti, venne impiccato in corso Vinzaglio a Torino dopo settimane di torture. Duccio Galimberti, avvocato di Cuneo, fu tra i fondatori delle brigate partigiane di Giustizia e Libertà e fu anch’egli fucilato dai fascisti nel gennaio del 1945. Basta entrare nel sito internet del Quirinale e cercare le motivazioni della medaglie d’oro al valor militare per vedere quante centinaia di nomi, di storie, di sacrifici, di eroismi abbiano costituito la parte migliore della Resistenza.
È chiaro che tale amnesia collettiva nazionale non è certo colpa di Giampaolo Pansa, come vorrebbero far credere i manutengoli dell’ideologia che vediamo, oggi, trionfare su giornali e televisioni. Ed è anche chiaro che, se solo fossimo consci del patrimonio di storia e di coscienza nazionale che stiamo perdendo, ignorando i molti eroi e le molte anime della Resistenza, cominceremmo a nutrire una rabbia sorda per quei farisei che si sono messi davanti alla porta della Storia e non hanno fatto entrare un’intera nazione: e tutto per sfruttare, ai propri fini politici, un’epopea che fu di gran parte di quella nazione, anche di quella che preferì seguire il destino degli ignavi e il cui onore fu salvato dal sacrificio di tanti. Certo, ogni 25 aprite, vi sono soltanto bandiere rosse nei cortei e chi cerca di entrarvi con un gagliardetto diverso è costretto, spesso, a sopportare insulti e aggressioni. In definitiva, sembra proprio che la Resistenza sia stata fatta solo dai comunisti o dai loro alleati; o meglio, da coloro che i comunisti sono disposti a legittimare come propri compagni di strada e, quindi, con una dignità di poco inferiore alla propria.
Il grande storico piemontese Raimondo Luraghi, partigiano nelle brigate monarchiche e medaglia d’argento al valor militare, ha precisato come fossero quattro i fronti della Resistenza: innanzitutto l’esercito, che nelle battaglie successive all’8 settembre ebbe 26.000 morti e che nelle operazioni del Corpo Italiano di Liberazione perse altri 20.000 caduti; i militari italiani all’estero (65.000 combattenti di cui 25.000 caduti); 650.000 militari deportati nei lager nazisti che non vollero giurare due volte, nonostante la prospettiva di disertare una volta rimpatriati (più di 30.000 morti di fame e di tifo); e, last but not least, i 70.000 combattenti che militavano nelle file partigiane al 25 aprile ma il cui numero, data l’estrema volatilità dell’impegno, fu di 220.000 patrioti civili nel corso della guerra.
Uno studioso come Virgilio Ilari afferma che il grado di mobilitazione della Resistenza italiana fu il più alto dell’Europa occidentale. E chi fu, allora, a fare la Resistenza? I comunisti e i laicisti di sinistra? Secondo Giorgio Bocca le poche migliaia di partigiani dell’autunno ‘43 sono molti per un paese «senza rivoluzione borghese e senza Riforma» e che non aveva più conosciuto una guerra popolare «dai tempi dell’imperatore Federico Barbarossa». Siamo qui in presenza di pregiudizi privi di fondamento e che non considerano per esempio le insorgenze antinapoleoniche, ben conosciute ai nostri lettori. E, comunque, Francia, Belgio, Olanda, avevano avuto la Riforma ad ebbero anche un alto tasso di collaborazionismo, più alto di quello italiano. Quanto alla “riformata” Germania nazista, “il tacere e bello”.
Sempre Virgilio Ilari ha quantificato il peso delle diverse componenti resistenziali. Si può dire, grosso modo, che il numero dei garibaldini comunisti fu intorno al 46% del totale, e che si batterono con eroismo spesso suicida, spesso imposto da ordini di partito che portavano a gloriose a sanguinose disfatte. Va inoltre calcolato che tale numero comprende anche coloro che facevano parte di tali formazioni, ma non ne riflette necessariamente l’orientamento ideologico. Chi andava in montagna, spesso non aveva scelta che quella di entrare nella formazione più vicina. Basti pensare che Pier Bellini delle Stelle, che catturò Mussolini, era cattolico e vicecomandante delta 52° brigata Garibaldi. Qualcuno può poi rimanere sorpreso nello scoprire che molti eroi partigiani avevano combattuto contro i comunisti nella guerra di Spagna. Il colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, che seppe resistere allo strappo dei denti e delle unghie in via Tasso e fu trucidato alle Ardeatine; o il tenente Edgardo Sogno, conte Rata del Vallino, protagonista di beffe e sabotaggi, di audacia senza pari e che, nel 1944, liberò un gruppo di partigiani fatti prigionieri a Milano, travestendosi da ufficiale delle S.S. italiane e disarmando i militi fascisti, rinchiudendoli poi in uno stanzino; o il tenente colonnello Guido Rampini, ufficiale franchista fucilato a Bergamo dai fascisti. Tra i più alti gradi del Comitato di Liberazione nazionale Alta Italia troviamo il monarchico Raffaele Cadorna, eroe della difesa di Roma, il democristiano Enrico Mattei e il quasi dimenticato Alfredo Pizzoni, il vero artefice del flusso di denaro che tenne in vita la Resistenza.
Quanto ai cattolici, oltre ai sacerdoti che, disarmati, diedero la vita per i propri fratelli, vi sono coloro che combatterono con le armi contro i nazisti che saccheggiavano l’Italia a contro i fascisti che li aiutavano: proprio come era accaduto al tempo delle insorgenze antinapoleoniche. Erano cattoliche le formazioni “Alfredo di Dio”, le “Brigate del Popolo”, le “Fiamme Verdi” e le “Osoppo Friuli”, ma ci fu chi scese in campo quasi da solo o con pochi amici, come Giancarlo Puecher, fucilato a Erba il 23 dicembre 1943. «Trasportato sul luogo del supplizio — così recita la motivazione della medaglia d’oro alla memoria — chiese di conoscere il nome dei suoi esecutori per ricordarli nelle preghiere di quell’aldilà in cui fermamente credeva, e tutti i presenti abbracciò e baciò, pronunciando parole nobilissime di perdono e rincuorando coloro che esitavano di fronte al delitto da compiere».
Puecher era solo il primo di una lunga lista di eroi oggi sconosciuti: Pietro Augusto Dacomo che, sui muri della cella, scrisse col sangue l’incipit del Paternoster e la frase «Nella vita si giura una volta sola»; Renato Del Din delle “Osoppo” caduto alla testa dei suoi uomini; i fratelli Antonio e Alfredo Di Dio, morti in combattimento nella val d’Ossola; Luigino Pierobon, cattolico militante nella brigata “Garemi”; Giovanni Ceron, che con un gruppo dl giovani dell’Azione Cattolica diede vita alla brigata “G. Negri” e che venne bruciato vivo dai nazisti; Antonio Schivardi e Antonio Lorenzetti delle “Fiamme verdi”, uccisi per aver protetto la ritirata dei propri compagni; Emiliano Rinaldini che, circondato dalle Brigate Nere, si aprì la strada sparando, attirando l’attenzione del nemico su di sé, fino alla cattura e alla morte; Giovanni Carli, caduto mentre attaccava una colonna nazista nei giorni dell’insurrezione. A volte la guerriglia vide anche battaglie di notevole ampiezza, dove l’addestramento e la disciplina fruttarono la vittoria, come al passo del Mortirolo, chiuso dalle “Fiamme Verdi”, che respinsero due offensive nazifasciste nel marzo e nell’aprile del 1945 o in Val Pesio, dove le formazioni del capitano Cosa sfuggirono all’accerchiamento e contrattaccarono con abilità, infliggendo dure perdite.
Tanto spirito di sacrificio, spesso, venne ricambiato con l’odio settario e con l’omicidio. È appena il caso di ricordare lo stato maggiore della “Osoppo” sterminato a Porzus «da mano fraterna nemica» e il suo comandante Francesco De Gregori, e assieme a lui i tre protagonisti de I giusti del 25 aprile: ll tenente colonnello Edoardo Alessi, il capitano Ugo Ricci e il tenente Aldo Gastaldi. Sulla morte di tutti e tre pesano pesanti sospetti che, anche in questi casi, sia stata «una mano fraterna nemica» ad assassinarli, ma non è questo il punto che preme di più oggi.
Ciò che è più urgente è riportare alla luce eroi come Aldo Gastaldi, il leggendario comandante “Bisagno” per il cui ritratto, ancora una volta, dobbiamo ringraziare Pansa. «Sembrava il personaggio di un film sui cavalieri di re Artù. Alto, atletico, una barba corta tra il biondo e il rosso, un coraggio spericolato, altruista, cattolico dalla testa ai piedi, di un’austerità da frate, tutto dedito alla sua idea fissa: tirare su una formazione di ribelli capaci di mandare al tappeto la Germania di Hitler e la repubblichetta di Mussolini. Sino all’ultimo ha ripetuto il suo credo: non si doveva odiare il nemico, ma soltanto combatterlo, non si doveva torturare, fare rappresaglie, fregarsene dei danni ai civili, e ai comandanti spettava l’onore di sacrificarsi per tutti». Fu la sua Fede e il rispetto per la vita umana, nei limiti della guerra, a ispirare la preghiera della sua divisione Cichero: «Vergine Maria, Madre di Dio, rendimi un patriota intelligente e onesto nella vita, intrepido nelle battaglie, sicuro nel pericolo, calmo e generoso nella vittoria. Accetta i sacrifici e le rinunce della mia vita partigiana e concedimi di raggiungere, con purezza d’intenzioni, l’ideale che donerà alla Patria, con lo splendore delle antiche tradizioni, l’ebbrezza di nuove altissime mete».
Come re Artù, la regale grandezza di “Bisagno”, dopo decenni di oblio, tornerà a ispirare gli animi dei cristiani e li porterà a una nuova Resistenza contro tutti i totalitarismi che, oggi come ieri, cercheranno di distruggere la Chiesa.


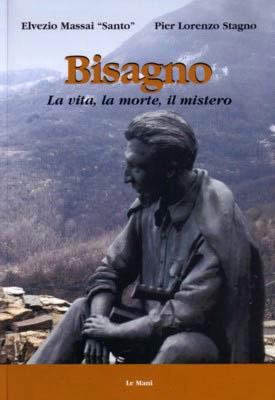


Avvenire
IL CASO
Nuove indagini su tre grandi comandanti partigiani cattolici
morti in circostanze sospette
L'ipotesi: furono eliminati dai "colleghi" comunisti
Chi ha ucciso "Bisagno"?
Di Roberto Beretta
Per nome di battaglia aveva scelto "Bisagno": come il torrente che
attraversa Genova, in apparenza tranquillo e modesto, furioso però
nelle sue inondazioni. E difatti di quel corso d'acqua aveva un pò
il carattere, calmo e riflessivo d'abitudine ma leonino in combattimento.
Per questo Aldo Gastaldi era un capo nato; per questo i suoi duemila
uomini cantavano in suo onore "Bisagno, Bisagno, cosa importa
se si muore?".
Primo di nome (la sua forza fisica, il suo coraggio, la sua intelligenza,
la sua moralità, la sua fede, la sua autorità, e il suo "mito" erano
indiscutibili in tutta la zona appenninica tra Lombardia, Piemonte, Emilia
e Liguria) e di fatto: perché subito dopo l'8 settembre il sottotenente
Gastaldi era riuscito a salvare dai nazisti le armi del suo reggimento a
Chiavari e aveva fondato la divisione partigiana Cichero, poi divenuta
leggendaria.
Lui però è rimasto un "eroe dimenticato", come gli altri due
comandanti partigiani Ugo Ricci ed Edoardo Alessi che a Milano
un convegno si propone di riesumare alla storia, accomunandoli grazie
alle loro caratteristiche: tutt'e tre infatti erano ufficiali del Regio
Esercito saliti in montagna dopo l'armistizio, tutt'e tre cattolici,
tutt'e tre morti in circostanze misteriose che la giornata milanese
chiede appunto di ridiscutere.
Il solito "revisionismo"? Beh, se anche fosse, ce n'è materia. Il genovese
Ricci, per esempio, capo della Resistenza in Val d'Intelvi tra i laghi di
Como e di Lugano, morì il 3 ottobre 1944 con 5 partigiani mentre tentava
di rapire il ministro repubblichino Buffarini Guidi per scambiarlo con altri
prigionieri; pare che i militi fascisti lo aspettassero al varco, avvisati
da qualche spia, e che addirittura Ricci fu ucciso dai mitra di certi suoi
stessi "compagni"...
Idem Alessi, tenente colonnello dei carabinieri e comandante partigiano
in Valtellina, ucciso ufficialmente da "sbandati fascisti" il 26 aprile
1945: guarda caso, aveva promesso che con lui non ci sarebbero state
giustizie sommarie contro i fascisti dopo la Liberazione...
E poi "Bisagno", che morì un mese più tardi per un incidente stradale
che non ha mai convinto nessuno dei suoi tanti amici, a cominciare da
monsignor Angelo Bassi - prete-partigiano del vogherese appena
insignito del titolo di "Giusto fra le nazioni" per aver salvato una
famiglia di ebrei - il quale non esita a sostenere che Gastaldi
"fu fatto fuori".
Da chi? Alcuni studiosi hanno riesaminato i tre casi e ne riferiranno
domani, prima di far confluire i loro dati in un libro curato dallo storico
Luciano Garibaldi per le edizioni Ares. L'ipotesi è forte: i tre partigiani
cattolici furono eliminati dai loro stessi "colleghi" però di ideologia
diversa, perché si opponevano alla politicizzazione della Resistenza in
senso comunista. "Allo stato delle ricerche - s'impegna Alessandro Rivali,
che ha visto i documenti e ne riferisce sul prossimo numero de Il
Domenicale - sembra pressoché sicuro che a decretare la loro morte
sia stata la divergenza con i comandi delle Brigate Garibaldi".
Non è da meno Dino Lunetti, compagno d'arme di "Bisagno",
in un'intervista al giornalista Riccardo Caniato destinata al libro
sopra citato: Gastaldi - che secondo la versione ufficiale finì sotto
un rimorchio in Veneto, sarebbe stato in realtà avvelenato.
Le rivelazioni di Lunetti sono esplosive ma documentate: è assai
strano che "Bisagno", il quale si trovava sopra la cabina del camion,
sia finito sotto le ruote posteriori del rimorchio (la cui presenza
al traino è peraltro dubbia); inoltre Lunetti non notò nessuno
sfondamento del torace sulla salma, mentre fu testimone di varie
iniezioni praticate al cadavere da un medico partigiano (che poi
negò tutto). È pure strano che Gastaldi, tipo atletico e allenato,
sia morto per un incidente banale.
A meno che, ipotizza Lunetti, durante una sosta "Bisagno" non sia stato
avvelenato, o almeno intontito per rallentare i suoi riflessi e provocare
la caduta. Infatti - sostiene - da quel momento il comandante partigiano
"cominciò a comportarsi in modo strano", distribuendo ai suoi uomini gli
effetti personali e persino i soldi della cassa, singolare "da parte di un
ufficiale che aveva sempre custodito con cura i suoi documenti" ma
comprensibile per chi voleva far "intendere ai presenti di aver compreso
la sorte che gli era stata riservata".
A ciò si devono aggiungere le reticenze, le ritrattazioni, le "pesanti
contraddizioni e sorprendenti lacune" nelle testimonianze su quella morte,
compreso il luogo in cui sarebbe avvenuta e ciò che successe in ospedale.
"Bisagno" - di cui, grazie ad alcune lettere ora recuperate, riemerge
l'altissima personalità morale e cristiana - era già stato oggetto nel
marzo 1945 di un tentativo di destituzione ad opera dei comandi comunisti
[in quella occasione si sfiorò lo scontro a fuoco tra i partigiani comunisti
e quelli cattolici] e si sentiva minacciato. "In definitiva - conclude
Lunetti -, sebbene come privato cittadino non posso avere prove certe,
sono convinto che Bisagno sia stato effettivamente assassinato".
Un convegno ha reso giustizia a tre partigiani ingiustamente
caduti nell'oblio
Dimenticati perché non comunisti: ecco l'altra faccia della Resistenza
MIRKO MOLTENI
Per quanto tempo una certa storiografia deviata ha sopravvalutato
il ruolo dei comunisti nella Resistenza avutasi fra il settembre 1943
e l'aprile 1945? Non va dimenticato che in grandissima parte
la Resistenza italiana fu espressione dei più vari raggruppamenti
non-comunisti, dal mondo cattolico, a quello monarchico,
a quello degli ex-ufficiali, galassie spesso intrecciate fra loro.
Parimenti non devono cadere nell'oblio figure di eroi oggi poco note.
Ecco perchè assume particolare rilevanza il convegno storico
"Resistenza in Lombardia: gli eroi dimenticati", tenutosi a Milano,
al Circolo di via Marina, e dedicato all'epopea di tre comandanti
partigiani, tre cattolici accomunati da una triste sorte essendo morti
in circostanze poco chiare.
Organizzato dall'Associazione Ricerche e Studi ARES e dalla Regione
Lombardia, il convegno ha visto come principale promotore il prof.
Luciano Garibaldi.
E' stata un'occasione non solo per rievocare l'audacia e il senso
del dovere di Aldo Gastaldi, Ugo Ricci ed Edoardo Alessi, tre
ufficiali del Regio Esercito che si sono dati alla macchia dopo
l'armistizio badogliano, ma anche per tracciare un bilancio
della Resistenza, al di fuori delle rappresentazioni oleografiche.
UN FENOMENO PLURALISTA
All'avvio del convegno, la prolusione dell'Assessore Regionale alle
Culture, Identità e Autonomie, prof. Ettore A. Albertoni, ha fortemente
contribuito a inquadrare la guerra partigiana in tutta la sua complessità.
«Anzitutto, -ha esordito Albertoni - riconoscendo in Luciano Garibaldi
un vero studioso di razza, mi preme sottolineare che non ha senso parlare
di revisionismo. Come evidenziato già nel 1991 da Claudio Pavone
nel suo celebre libro "Una guerra civile", la Resistenza fu un fenomeno
dalla grande complessità, che racchiuse in pratica tre guerre in una.
Tanti ufficiali delle Forze Armate, all'armistizio dell'8 settembre
1943, compirono scelte coraggiose animati dal senso del dovere
e dalla lealtà verso il governo monarchico.
Fu così animata una guerra patriottica, individuando nel Regno
lo Stato legittimo, ora affiancato agli Alleati.
Su questa valenza si innestò quella della guerra civile tra italiani,
risultante dallo scontro fra i partigiani espressione dell'Italia
resistenziale e i fascisti della Repubblica Sociale, che sotto la guida
dell'ultimo Mussolini avevano recuperato le loro lontane origini
repubblicane del 1919.
Infine, sul versante comunista, la lotta fu spesso interpretata
come una vera guerra di classe, preludio alla rivoluzione.
La lotta partigiana fu dunque assai più complessa di quanto
certe semplificazioni potrebbero far credere...».
TROPPI MISTERI ANCORA INSOLUTI
Gli altri relatori, i professori Pier Lorenzo Stagno, Gabriele Pagani
e Michele Maurino, hanno tratteggiato le vicende dei tre comandanti
dimenticati. A cominciare da quel tenente Aldo Gastaldi che pochi
giorni dopo la fine della guerra fu investito da un camion in circostanze
poco chiare.
Noto col nome di battaglia "Bisagno", questo ufficiale d'artiglieria
genovese è stato definito "il primo partigiano d'Italia", con riferimento
al fatto che già l'8 settembre 1943 evitò che i nazisti catturassero le armi
del 15° Reggimento Genio di Chiavari. Nei mesi seguenti il cattolico
Gastaldi arrivò a comandare la divisione partigiana "Cichero", di oltre
2000 uomini, che dava del filo da torcere alla Wehrmacht fra la Liguria
e l'Emilia. Con la Liberazione, Gastaldi non si dimostrò certo disposto
(a differenza di altre parti politiche) ad attuare violenze e vendette
ormai inutili e crudeli una volta finito il conflitto. Si adoperò anzi
perchè i militari della disciolta Repubblica Sociale, prigionieri
dei partigiani, potessero tornare alle loro famiglie.
Il 21 maggio 1945 Aldo Gastaldi subiva presso il Lago di Garda
il misterioso e mortale incidente. Quell'esempio di bontà e perdono
cristiano aveva suscitato l'odio di qualcuno?
Altrettanto misterioso il destino del capitano Ugo Ricci, che alla data
dell'armistizio era di stanza presso Cantù. Guadagnata la Val d'Intelvi,
Ricci vincolò sè stesso e i suoi 23 uomini alla resistenza con un solenne
giuramento sottoscritto il 14 dicembre 1943 nel santuario di San Pancrazio
a Ramponio (giuramento ricordato ogni anno con una Messa).


Ricci animò la guerriglia in quell'angolo di Lombardia, ma morì
durante un'azione che prevedeva il rapimento del Ministro degli Interni
della Repubblica Sociale, Guido Buffarini-Guidi. Era il 3 ottobre 1944
e l'episodio, noto come "battaglia di Lenno" finì male perchè pare che
i partigiani fossero stati traditi da qualcuno. Quando Ricci e il suo gruppo
attaccarono i fascisti pensando di prenderli di sorpresa, questi si erano
già preparati ad "accogliere" i partigiani. Non si è mai saputo il nome
dell'eventuale traditore, ma a 60 anni di distanza l'ormai anziana staffetta
partigiana Marisella Sormani, che fu fidanzata di Ricci, continua
a ricercare la verità.
Che dire invece del colonnello dei Carabinieri Edoardo Alessi,
che comandò la Prima Divisione Alpina "Valtellina" per essere ucciso
da ignoti il giorno successivo alla Liberazione?
Come Gastaldi, anche il comandante Alessi aveva promesso di evitare
violenze dopo la fine delle ostilità. Un intento a indubbio vantaggio
degli sconfitti. Per quale motivo, quindi, sarebbero stati degli "sbandati
fascisti", secondo la versione ufficiale, a ucciderlo il 26 aprile 1945?
Gli fu concessa la Medaglia d'Argento postuma e gli venne intitolata
la caserma dei Carabinieri di Sondrio, ma dopo più di mezzo secolo
anche Edoardo Alessi, come tante altre vittime di quel triste periodo,
sia fascisti sia partigiani, chiede ancora giustizia.
BIBLIOGRAFIA
Luciano Garibaldi (con Riccardo Caniato, Luigi Confalonieri,
Alessandro Rivali) I Giusti del 25 Aprile. Chi uccise i partigiani eroi?,
Ares, 2005. Testo coraggioso, pubblicato a 60 anni dalla Liberazione,
racconta la vita eroica e la misteriosa morte di tre protagonisti della
guerra partigiana, scomodi e perciò dimenticati in fretta: Aldo Gastaldi
«Bisagno», comandante della leggendaria Divisione «Cichero»
che combatté sull'Appennino ligure-emiliano, Ugo Ricci,
«il Capitano», l'eroe della Resistenza in Val d'Intelvi,
ed Edoardo Alessi, «Marcello», comandante della «Prima
Divisione Alpina Valtellina».
Tutti e tre ufficiali dell’ Esercito e uniti da una comune
e intensa fede religiosa, puntavano a una pronta riconciliazione
col nemico sconfitto: se fossero vissuti avrebbero impedito
che venisse sparso il «sangue dei vinti».
Per questo due di essi furono uccisi nel momento culminante
della loro battaglia e il terzo, la medaglia d'oro Aldo Gastaldi,
ruzzolò, o fu fatto ruzzolare, sotto le ruote di un camion.
Luciano Garibaldi (con R. Caniato, L. Confalonieri, A. Rivali)
I giusti del 25 aprile. Chi uccise i partigiani eroi?
recensione di Paolo Smeraldi
Mentre la generazione della Resistenza si avvia al tramonto,
il muro dell'ideologia che aveva monopolizzato la divulgazione
sulla lotta partigiana sembra indebolirsi, forse anche per un superamento
della tradizionale identità comunista da parte dei partiti e degli intellettuali
di sinistra.
Militari, cattolici, anticomunisti; queste le caratteristiche comuni dei tre
«partigiani eroi» protagonisti del libro di Garibaldi. Il primo ritratto è
per il genovese Aldo Gastaldi «Bisagno», partigiano fin dall'8 settembre
del 1943, capo della formazione «Cichero», che operava in Liguria.
Il regolamento della «Cichero» impediva di molestare le donne,
imponeva di pagare le derrate alimentari prese ai contadini, vietava
le bestemmie.
Il comandante Bisagno mostrava un coraggio indiscutibile, ma evitava
di esporre i suoi uomini ad imprese velleitarie e cercava, nei limiti
del possibile, di conquistare alla sua causa i fascisti più con la persuasione
che con le minacce.
Bisagno denunciò apertamente i tentativi dei partigiani comunisti
di «orientare» politicamente le formazioni combattenti, a detrimento
delle operazioni contro il nemico comune; per questo, fu prima invitato
a farsi da parte e poi costretto ad accettare la divisione della sua «Cichero»
in due formazioni. Finita la guerra, l'eroe genovese fu escluso dalla spartizione
delle «poltrone» e dovette assistere con sgomento alle feroci vendette
contro ex-fascisti e personaggi scomodi. Il 21 maggio 1945, Gastaldi morì
sotto le ruote di un camion, fra sospetti di avvelenamento mai fugati per
la mancanza di autopsia. La dinamica dell'incidente non fu mai chiarita
per le discordanze fra i testimoni, al punto che perfino il luogo esatto
in cui avvenne è rimasto incerto.
Il tenente colonnello Edoardo Alessi, carabiniere originario della Valle
d'Aosta, compì le sue gesta in Valtellina. Nell'imminenza dell'armistizio
coprì la fuga dei renitenti alla leva e l'emigrazione in svizzera degli
ebrei. Nel dicembre del 1943 fu pertanto costretto a riparare in Svizzera,
dove nel maggio 1944 fu cooptato come addetto militare a sostegno
della Resistenza da Campione d'Italia.
Anche qui la sua indipendenza di giudizio gli guadagnò numerose
antipatie; fu esonerato dall'incarico e nel febbraio 1945 scelse la via
della clandestinità. In Valtellina prese il comando di una formazione
di «Giustizia e Libertà», ma presto eliminò dal nome ogni riferimento
a quest'area politica per sottolineare il suo carattere solo militare. Allo
stesso modo, non volle sentire parlare di commissari politici, sostenendo
che essi fossero «tutti targati PCI». Come Bisagno, anche Alessi morì
in circostanze poco chiare addirittura il 26 aprile del 1945; fu ucciso
in uno scontro a fuoco insieme al suo aiutante di campo, non è chiaro
se da fascisti o da altri partigiani, nel corso di un trasferimento notturno.
Nemmeno sul suo cadavere fu effettuata l'autopsia.
L'ultimo caso raccolto da Garibaldi è quello del capitano autiere Ugo Ricci,
operante in Val d'Intelvi fin dal settembre 1943. Come Bisagno, Ricci era
un fervente cattolico, militare tutto d'un pezzo che, avendo nel suo già
una qualifica ben precisa, non adottò alcun nome di battaglia. Anticomunista
convinto, Ricci aveva un coraggio fuori dal comune ed un altrettanto
notevole rispetto per la vita umana: penetrato nottetempo con i suoi uomini
in una caserma della Decima Mas, risparmiò la vita ai diciotto militi
presenti limitandosi a prelevare tutte le armi disponibili.
Ben presto finì nel mirino dei garibaldini operanti in zona, i quali
in un paio di occasioni tentarono di arrestarlo, con la forza o con
false accuse di corruzione. Il 3 ottobre del 1944 Ricci fu incaricato
di catturare il ministro della RSI Buffarini-Guidi, teoricamente
di passaggio a Lenno. Di fatto, quella sera Ricci ed i suoi uomini
si diressero in paese, senza il sostegno promesso dai garibaldini,
che non si presentarono all'appuntamento; in compenso, invece
del ministro trovarono ad attenderli
le truppe repubblichine, avvertite in anticipo. Subito si scatenò
un combattimento, nel quale Ricci perse la vita; per anni suo padre
tentò invano di fare chiarezza sulle circostanze della sua morte, senza
riuscire ad arrivare a nessuna conclusione certa.
Se i partigiani studiati da Garibaldi si spensero in circostanze oscure,
la chiarezza della loro visione emerge però nettamente dalle pagine
del libro: uomini pragmatici, vivevano la Resistenza come costruttori
di pace, non come alfieri di future rovinose rivoluzioni.
Chi uccise i partigiani eroi?
Intervistiamo Luciano Garibaldi, autore del libro che dice la nostra
verità sulla "resistenza".
Si dice che, con questo libro, hai compiuto un tentativo di estromettere
i partigiani comunisti dalla Resistenza
Ho semplicemente dimostrato che se non si può affermare che tutti
i partigiani comunisti furono degli assassini, si deve purtroppo convenire
che tutti i partigiani assassini erano comunisti. La storia dei miei «tre eroi»
lo dimostra ad abundantiam.
Ce la puoi sintetizzare?
Certo. Aldo Gastaldi «Bisagno», forse il più celebre dei tre, il primo
partigiano d'Italia, il leggendario comandante della divisione «Cichero»
che dominò per 18 mesi l'Appennino ligure-emiliano, faceva la Comunione
tutte le mattine, proibiva ai suoi uomini di bestemmiare e soprattutto
li esortava a non uccidere, ma a convincere gli avversari.
Ed era talmente convincente lui stesso da essere riuscito
a portare nelle sue file un intero Battaglione della «Monterosa».
Più volte venuto ai ferri corti con i comandanti comunisti della Resistenza
in Liguria, specialmente dopo l'inizio dello spargimento del «sangue
dei vinti» iniziato all'indomani del 25 aprile, finì misteriosamente sotto
le ruote di un camion con il quale aveva riportato a casa, in Lombardia,
i ragazzi ex fascisti che lo avevano seguito sui monti.
Gli altri due chi erano?
Andiamo con ordine. Il tenente colonnello dei Carabinieri Edoardo
Alessi era il comandante della Divisione Partigiana Alpina Valtellina.
Aveva la sua base nelle vallate attorno a Sondrio ed era diventato un mito
per gli ebrei in fuga: ne aveva salvati a centinaia aiutandoli a raggiungere
la Svizzera. Era profondamente cattolico.
Come morì il colonnello Alessi?
Ammazzato da un gruppo di fascisti in fuga, recita la vulgata, ma la morte
di Alessi era l'ultima cosa che i fascisti, ormai vinti, avrebbero voluto.
Essi infatti sapevano che, con lui al comando, se la sarebbero potuta
cavare. E invece, lui morto, furono massacrati come bestie da macello.
Chi è il terzo dei tuoi Giusti?
Il capitano degli Autieri Ugo Ricci, un trentenne che, l'8 settembre,
scelse di piazzarsi con i suoi uomini in Val d'Intelvi dove fu
protagonista di azioni militari leggendarie come l'occupazione
del comando della Decima Mas senza colpo ferire.
Ho trovato - e pubblicato - la testimonianza di un prete che riferisce
come non solo Ricci facesse, anch'egli, come «Bisagno», la Comunione
tutte le mattine, ma anche, ogni volta che doveva prendere una decisione
drastica e gravissima, ritornasse «per sentire il mio parere», scrive
don Scacchi, «e il mio giudizio di sacerdote e a quello si attenesse
completamente, così che nessuno fu da lui soppresso come pure
avrebbero richiesto circostanze e ordini. Valsero invece, in questi
casi, l'opera sua persuasiva e il suo stesso ascendente». Insomma,
era un combattente, ma non un sanguinario.
E' quasi impossibile immaginare un partigiano del genere.
Mica vero. Personalmente ne ho conosciuti alcuni. Molti monarchici,
molti cattolici, tutti visceralmente anticomunisti. Un nome per tutti:
Edgardo Sogno, di cui fui il biografo.
Peccato che persone di quella levatura siano morte così giovani.
Già, peccato: giusto in tempo per non riuscire ad impedire che i vincitori
si trasformassero in boia e inondassero l'Italia del Nord del sangue
dei vinti.


Fine prima parte.
-
24-04-12, 02:09 #9Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
Seconda parte
Il giorno in cui Bisagno rifiutò di cedere le armi ai tedeschi
di Prospero Schiaffino
Mi sembra quanto mai utile ricordare Aldo Gastaldi, detto Bisagno,
assieme ad Edgardo Sogno (il famoso Franchi), entrambi
decorati di Medaglia d'Oro, entrambi cattolici (e monarchici).
Bisagno forse (anzi senza forse) fu assassinato o fatto uccidere
dagli stessi partigiani (comunisti e da essi aveva anche subito minacce
ed attentati durante la stessa Resistenza) perché, avvenuta la Liberazione,
aveva deciso di regolare tutti i conti «per i delitti, le ruberie, gli assassini
e i reati comuni, commessi proprio in nome della Resistenza».
Aldo Gastaldi, nato a Genova nel 1921 fu il primo partigiano d'Italia,
infatti l'8 settembre alle 1943 (l'infame e vile annuncio del Maresciallo
Badoglio, che lasciava tutto l'esercito italiano allo sbando) si trovava
nella caserma di Chiavari col grado di sottotenente della III Compagnia
Marconisti e di fronte «al fuggi-fuggi generale non perse la sua calma,
restò vicino ai suoi soldati e riuscì a convincerli ad aspettare qualche
giorno.
Verso le 10.30 del 9 settembre giunsero due sergenti, i quali annunciarono
al sottotenente l'avvenuta occupazione della caserma da parte dei tedeschi
e che tutte le armi del Reggimento erano custodite, ridotte ad un fascio
e accumulate nel cortile. Aldo rimase pensoso, il pallore del suo volto
mostrava tutta la sua sofferenza e poi rivolto ai suoi uomini disse
con estrema semplicità: «Ma le nostre armi non passeranno nelle mani
dei tedeschi».
Unanimità del consenso dei suoi uomini, pochi semplici soldati. Lo stesso
sottotenente si era caricato sulle spalle una considerevole quantità di armi
sotto la «staffetta» del suo sergente Walter Morandini e seguito dai suoi
coraggiosi soldati, anche essi pieni di armi, con la complicità di alcuni
chiavaresi, riuscì a convogliare tutto il carico nel cortile di una abitazione
di Chiavari.
Quello stesso giorno il sottotenente Aldo Gastaldi divenne «Bisagno»
il primo leggendario partigiano d'Italia (insieme a Edgardo Sogno)
Voglio citare, papale, papale, un pensiero espresso dallo stesso Bisagno
con riferimento ai contrasti avuti con i partigiani comunisti:
«Continuerò a gridare ogniqualvolta si vogliano fare ingiustizie, e griderò
contro chiunque, anche se il mio grido dovesse causarmi disgrazie od altro.
Non devo formarmi quassù la posizione per domani, io nulla attendo
dal domani a sfruttamento del mio lavoro di oggi; quanto ho dato e dò,
lo dò alla Patria, alla quale nulla si chiede».
E forse in questa sua nobilissima dichiarazione va da ricercarsi la causa
del suo sacrificio o meglio del suo assassinio da parte dei partigiani
comunisti, che avevano da giustificare le loro numerose «malefatte».
E dal recente libro «I giusti del 25 aprile - chi uccise i partigiani eroi»
del mio carissimo amico Luciano Garibaldi, illustre giornalista e storico,
mi viene la più completa conferma, perché Aldo Gastaldi, risulta morto
misteriosamente sotto le ruote di un camion, che ne ha stritolato il corpo
mentre portava a casa i suoi ragazzi, che avevano combattuto al suo fianco.
Assieme a Bisagno, il ten. col. dei Carabinieri Edoardo Alessi, comandante
della divisione partigiana «Valtellina» e il Cap. degli Autieri Ugo Ricci,
comandante della Resistenza in Val d'Intelvi uccisi proditoriamente ancora
adesso si attende chiarimento e giustizia, come del resto di molti altri,
come quello delle bande in Val d'Osoppo.
Tre morti mostruose, incivili e molto sospette. È l'ora di finirla:
su questi delitti bisogna fare luce.
Il Giornale
Il mistero sulla fine di «Bisagno»
di Prospero Schiaffino
Parla Elvezio Massai, amico del celebre comandante partigiano
Recentemente mi sono recato a trovare Elvezio Massai, «Santo»


amico del Mitico Bisagno e decorato di medaglia d'argento
e bronzo al valor militare.
Elvezio, che abita a Sori al piano terra di una caratteristica casetta
vicino al mare, dalle cui finestre penetra un caldo «gettito» di sole
che la rischiara tutta, mi ha accolto come un vecchio amico, anche se
era la prima volta che l'incontravo e mi ha subito detto «diamoci del tu».
A casa sua lo ho incontrato in compagnia di un altro celeberrimo
personaggio, il campione olimpico Eraldo Pizzo, il caimano, suo
carissimo amico e che frequenta spesso e lo chiama col genovesissimo
dialettale «veziu».
Sulla mia specifica domanda: «Bisagno è stato ucciso?», risponde:
«Tutti o quasi lo pensano, ma non si può dire e del resto nel libro scritto
da me e da P.L. Stagno tutto è piuttosto chiaro e specificato».
E lancia anche il dubbio «che fosse stato avvelenato in occasione
del suo viaggio a guerra finita» e prima di cadere, o forse fatto cadere,
dalla vettura.
Bisagno era un puro, un idealista, cattolico e monarchico
(del resto ufficiale del regio esercito) e a volte anche troppo
rispettoso nei confronti dei superiori.
Elvezio Massai prima dell'8 settembre 1943 aveva combattuto
in Sicilia, e in quello stesso tragico giorno si trovava in convalescenza
a Recco. Ed è sulla piazza della chiesa che apprese del messaggio ambiguo
e malefico del maresciallo Badoglio. Subito dopo, su consiglio del padre,
prosegue Elvezio, si recò a Baiardo, ma poco dopo, non resistendo nella
sua posizione di ambiguità, si recò in montagna con la divisione «Cichero»
guidata da Bisagno.
Il glorioso ed eroico comandante e primo partigiano d'Italia era da tempo
tenuto d'occhio da Barontini, poi deputato del Pci ed agente del Kgb
sovietico, che voleva a tutti i costi farlo fuori, o perlomeno dismetterlo
o silurarlo.
Al momento dell'episodio di Fascia, narrato nel libro «Bisagno», Aldo
Gastaldi fu convocato in quella località per essere esautorato. Però
per fortuna, o forse per convinzione, Gastaldi aveva avvertito Elvezio,
dislocato a quel tempo a Loco, di seguirlo, perché non si sentiva tranquillo
e non sapeva cosa sarebbe successo. O forse lo sapeva fin troppo bene.
Prudentemente, ed aggiungo io opportunamente, Elvezio Massai
non solo aderì all'invito o all'ordine del suo comandante, ma si preoccupò
di farsi accompagnare da un folto gruppo dei suoi partigiani armati di tutto
punto, il che evitò certamente la preordinata fine, del comandante della «Cichero».
«Santo», imbracciato il mitra, entra nella sala del locale, ove Barontini
e altri capi partigiani (Pci) stavano per disporre l’eliminazione di Bisagno,
e avrebbe sicuramente sparato per salvare il suo comandante (avendo
anche predisposto l'intervento dei suoi alpini) ma lo stesso Gastaldi
con un segno della mano gli fece capire di fermarsi.
Dopo la sua misteriosa morte, Elvezio Massai aveva preso accordo
con il fratello di Bisagno per fare una autopsia sul corpo del comandante,
ma improvvisamente non si venne a capo di nulla, perché il fratello
di Bisagno (chi sa perché!) decise con il senatore Raimondo Ricci,
presidente dell'Anpi, di non volerne più sapere, nonostante che le sorelle
concordassero con «Santo».
Egli, tra l'altro, aveva interpellato un cugino di Bisagno, illustre chimico,
che aveva assicurato il suo intervento e che forse, anzi senza forse, avrebbe
potuto definire completamente tutta la storia.
Dopo questa decisione lo stesso Massai per protesta diede le dimissioni
da ogni carica nell'ambito del Consiglio e degli organi della Resistenza.
Alla fine della lunga chiacchierata Massai mi ha confessato che assieme
a P.L. Stagno sta lavorando ad un libro «sulle nefandezze sulle poco pulite
storie dell'ex Pci, e non solo».
Traslazione della salma di Aldo Gastaldi, "Bisagno"
Come venuto da un mondo migliore a combattere per il nostro mondo
ELENA BONO
Il 24 aprile 2005 i resti mortali di Aldo Gastaldi "Bisagno" sono stati
traslati dal Campo Trento e Trieste al Pantheon del Cimitero Monumentale
di Staglieno, dove riposano i genovesi più illustri.
È la prima volta che un eroe della Resistenza viene accolto nel Pantheon
ed è stata una cerimonia toccante e suggestiva, alla presenza di numerose
autorità militari e cittadine, dei familiari, dei suoi compagni di allora,
e di numerosissimi cittadini.
Dopo la Messa celebrata sul Piazzale della Fede, con labaro avvolto
nella bandiera tricolore, il doveroso omaggio al giovane comandante
partigiano di soli 24 anni, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare.
In un articolo, intitolato “L’ultimo canto di Bisagno”,
tratto da Il Partigiano del 26 maggio 1945, troviamo
questa descrizione della figura di Aldo Gastaldi:
«Abbiamo accompagnato anche la salma di Bisagno: anch’egli,
assolto il suo compito, ci ha lasciati. Durante ogni rastrellamento
si spargeva la voce che il Comandante era morto: veniva da chissà
chi, forse dal nostro stesso timore di perderlo.
Ma poi egli giungeva tra noi a portare con la sua presenza nuovo
vigore, nuova decisione. Ora sappiamo che non lo vedremo più,
anche se non lo dimenticheremo mai: egli apparteneva al numero
di coloro la cui vita è una missione che deve essere assolta ad ogni
costo e Bisagno vi si impegnò senza misurare il pericolo, chiedendo
al suo corpo ogni sforzo, senza mai concedergli riposo nei 18 mesi
in cui fu partigiano.
Lo si vedeva dappertutto, a piedi, in motocicletta, in automobile,
al lavoro anche quando gli altri dormivano.
Andava negli accampamenti nemici vestito da alpino a prelevare
uomini, armi, a prendere informazioni; correva ovunque vi fosse
da sparare; nei rastrellamenti riusciva a tirar fuori dall’accerchiamento
intere brigate.
Per i suoi partigiani, per le popolazioni delle vallate che aveva liberato
era assai più che un capo: era la stessa vita partigiana.
Ed infatti il giovanissimo Comandante della più vecchia Divisione
è caduto tornando dall’aver accompagnato a casa i suoi uomini tornati
alla vita civile. Alla vita civile stava per tornare anche lui, ma era
difficile per noi immaginarlo privo della sua divisa, del suo Marlin;
non sapevamo vederlo fuori dai monti, fuori dagli scontri, dalle marce:
sembrava quasi che non avrebbe potuto vivere una vita diversa da quella
in cui durante 18 mesi aveva sofferto ogni risorsa del suo corpo,
del suo spirito.
Ed infatti lo abbiamo rivisto in una bara coperta di fiori; il volto
lungo con il pizzo biondo era sereno; qualcuno aveva deposto
ai piedi il Marlin, l’arma con la quale aveva vinto, e gli scarponi
che avevano percorso infaticabili tutti i sentieri, si erano coperti
del fango di ogni vallata, della neve di ogni monte.
Abbiamo accompagnato la sua bara, attraverso le strade
della sua città gremite di popolo commosso, circondata
dai suoi partigiani. Quando la bara, che fino a Piazza Manin
era stata portata a spalle dai compagni, fu deposta sul carro,
i partigiani le si strinsero di più intorno come se non volessero
lasciarla andar via. E gli occhi si riempirono di lacrime.
Bini, salì sul carro davanti alla bara: “Il nostro Bisagno,
il Comandante della Divisione Partigiana Cichero,
il primo partigiano d’Italia, non era un uomo da discorsi.
Egli si esprimeva con l’esempio: nei combattimenti
dove era sempre presente ovunque fosse impegnato
un distaccamento della Cichero, e nel rigore della sua vita.
E nei suoi compagni – noi che conserveremo sempre dentro
l’immagine di Bisagno piegato sull’arma a sparare– l’immagine
della sua faccia con la barba bionda mentre canta nel casone
illuminato dal fuoco, e noi tutt’attorno siamo contenti di
rispondere in coro. Lo salutiamo nel modo che egli preferisce,
cantando la canzone che amava. Cantiamo tutti insieme,
in onore del nostro Bisagno”.
Le ultime parole Bini le urlò perché il pianto non le soffocasse.
Intorno i compagni con i volti bagnati di lacrime cantarono:
Sui monti di Val Trebbia/c’e il partigiano/
che marcia alla riscossa/col suo Bisagno.
Le note della sua canzone, avevano una nuova tristezza:
Marzo, con la sua vecchia divisa partigiana, Bini, Dente,
Lesta e cento altri intorno alla bara piangevano come possono
piangere uomini che insieme hanno combattuto e sofferto.
Forse soltanto allora il popolo che era intorno ha compreso
chi fossero i partigiani, chi fosse Bisagno. Quel canto
intorno ad una bara ha detto a tutti che questa non racchiudeva
soltanto il primo partigiano d’Italia, ma con lui tutto ciò che
di leggendario, di eroico, c’è stato nella vita sui monti.
Quel canto salutava non soltanto il Comandante, ma ciò
che in questi mesi aveva per noi tutti rappresentato: il Partigiano.
Poi il carro si mosse, e gli uomini rimasero immobili a guardarlo
sparire; irrimediabilmente qualcosa se ne andava con lui
di giovane, di vivo, di eroico: questo era stato l’ultimo canto
con Bisagno».
Il comandante Bisagno partigiano e uomo di fede
Luciano Garibaldi
Chiedeva ai suoi combattenti il rispetto per le donne e proibiva
la bestemmia. Confidava in Dio e amava la Madonna. Morì
misteriosamente sotto le ruote di un camion nel pieno della
"caccia al fascista", scatenata dai comunisti il 25 aprile 1945.
Morto all'indomani della Liberazione, all'età di 24 anni non ancora
compiuti, Aldo Gastaldi, nome di battaglia «Bisagno», medaglia
d'oro al valor militare, il più luminoso ed eroico esponente
della Resistenza sull'Appennino ligure-emiliano, era animato
da una profonda, sentita e vissuta fede cattolica.
Quelli riassunti in questo articolo sono gli aspetti forse meno
conosciuti della sua eroica testimonianza. Incominciamo dal mitico
«codice di Cichero» (dal nome della località sopra Chiavari nella quale
«Bisagno», con i suoi soldati, diede inizio alla Resistenza, all'indomani
dell'8 settembre 1943, dopo avere portato con sé le armi della caserma
del Genio dove prestava servizio come ufficiale).
Tra i punti principali del «codice», c'erano i seguenti:
- è severamente proibito toccare le donne che non lo desiderano;
- sono rigorosamente vietati bestemmie e turpiloquio.
«Bisagno», da sempre cattolico convinto e osservante, scrisse
in proposito, in una direttiva ai suoi uomini: «La bestemmia è,
per chi crede, una abiezione e, per chi non crede, una stupida inutilità.
In ogni caso è simbolo di pervertimento».
Sempre in ordine alla fede religiosa di Gastaldi, vale riportare il seguente
aneddoto riferito dal figlio del partigiano Roberto Pisotti, nella cui abitazione
a Barchi, in alta Val Trebbia, provincia di Piacenza, «Bisagno» si era recato
il giorno di Natale, nel corso del gelido inverno del 1944.
Vicino alla casa di Pisotti c'era una piccola fontana completamente
ghiacciata. Lui voleva andare a Messa e ricevere la Santa Comunione.
Ruppe il ghiaccio e si lavò il busto e il viso per presentarsi pulito
alla Messa di Natale.
Non meno significative le sue raccomandazioni ai compagni
di contenere la violenza bellica cercando di risparmiare la vita
del nemico, e la più volte riaffermata intenzione di riappacificarsi
con i fascisti all'indomani della fine delle ostilità.
Nel giugno 1944, Gastaldi, alla testa dei suoi uomini, assaltò la caserma
di Rovegno della GNR prelevando armi, esplosivi e indumenti, senza
colpo ferire. A Ottone decise di liberare da solo alcuni dei suoi uomini
fatti prigionieri. Dopo avere strisciato pancia a terra nel campo
che i custodi-carcerieri utilizzavano come latrina all'aperto (e che
perciò nessuno sorvegliava) tornò alla propria base sporco in maniera
indecente, ma con i compagni liberati.
«L'arco portante della costruzione umana di Aldo» ricorda Dino
Lunetti, suo cugino e suo compagno di guerra nella Resistenza,
«era la fede cristiana. Aldo credeva, con profonda convinzione, in Dio,
essere supremo da cui tutto e tutti dipendono, lui per primo; credeva
nel Dio di amore di cui si sentiva figlio. In una lettera inviata il 2 maggio
1941 ai genitori aveva scritto: "Sono convinto che il Supremo Fattore,
tanto invocato specialmente da Te, Mamma, venga a regolare i miei
avvenimenti, tutti i miei avvenimenti e quelli della nostra famiglia"».
Il carteggio con i genitori è la prova documentale della fiducia che
«Bisagno» nutriva in Dio. Aveva capito che la vera forza di un uomo
non sta nell'accanirsi a perseguire obbiettivi propri, quanto nel saper
accettare con fiducia la volontà di Dio, anche quando si manifesta
in aperto contrasto con quella umana: «È necessario», scrisse in un'altra
lettera, «sapersi contenere, saper prendere tutte le cose dal lato buono,
e, soprattutto, saper confidare in Dio». E ancora: «Carissimi, se a Genova
facevo una vita regolare, qui la faccio regolarissima. Confido di essermi
tolto quel poco di ingiusto che ancora era in me».
Nel maggio '42 dovette affrontare una fastidiosa malattia.
Uscitone, scrisse: «Il resto del mese l'ho passato abbastanza bene
e ne ringrazio la nostra Madre e Patrona, nonché Signora di questo
gentile e ormai trascorso mese di maggio». Religione e poesia.
«È nella fede di mio cugino», ricorda ancora Dino Lunetti, «che si può
concepire la straordinarietà della sua figura. Solo una fede eccezionale
può guidare un uomo a imprese eccezionali. Chi l'ha conosciuto ne ricorda
l'indomita tenacia: ebbene, essa poggiava sull'assoluta certezza che, agendo
rettamente, l'aiuto di Dio non gli sarebbe mai venuto meno, per un risultato
finale sempre e soltanto buono, al di là di ogni apparenza. Scriveva ai
genitori il 3 agosto del 1943: "Mi auguro che tutto prosegua per il meglio;
Iddio fin qui mi ha guidato, e sarà sempre la mia sicura Guida. Ho sempre
fatto il mio dovere. Continuerò ad essere giusto e sincero; Dio disporrà di
me. Qualsiasi cosa avvenga io sarò contento, e dovrete esserlo anche voi".
Siamo di fronte alla riaffermazione di una saldezza di fede elevata a stile
di vita».
[In un'altra lettera riprende rispettosamente il padre, che qualche giorno
prima si era lasciato scappare un gesto d'ira nei confronti della madre:
"Caro Papà, Ti prego infinitamente di scusarmi se alla vigilia di Natale
ho trovato da ridire per il tuo nervosismo. Caro Babbo, se lo accetti, voglio
darTi un consiglio: non essere sempre pessimista e cerca di vedere le cose
qualche volta bianche. Prova a sforzarti di non arrabbiarTi e, qualsiasi
cosa avvenga, prendila con calma.
Caro Babbo, forse sono ancora giovane, ma la mia poca esperienza
è sufficiente per insegnarmi che nulla si rimedia o si guarisce con
la rabbia, mentre invece si guarisce l'inguaribile con la calma.
Per riuscire ad essere calmi, sono necessari due elementi: avere
una grande forza d'animo, e prendere le cose come Dio le manda;
siano esse buone o cattive, prenderle sempre per buone. Pensiamo
che se Dio così ha voluto, così è bene che sia.
Non si deve perdonare uno sbaglio? E' possibile non sbagliare mai?
Sapessi Papà, quanto si adopera la Mamma per non sbagliare di fronte
a Te! Eppure, talvolta, povera Mamma, sbaglia; e Tu non sei sempre
pronto al perdono.
Eppure sei molto buono d'animo, troppo buono. Lo si vede con gli estranei,
con i quali hai sempre paura di agire male. Perchè non vuoi usare questa
limpidezza d'animo con i Tuoi familiari, in ogni momento e sempre?
Caro Babbo, perdona tutto ciò, e mi auguro e Ti auguro che Iddio
voglia che Tu abbia una vita calma, di pace, che Ti apporTi maggiore
salute, oltre che gioia a Te e a noi. Il Tuo animo è buono: così sia
il tuo agire."
Molto significativa è un'altra lettera indirizzata al padre: "Comprendo
quale possa essere uno dei pensieri che maggiormente passa per la mente
di un padre che ha un figlio lontano da casa. Alludo cioè al dubbio che
può tormentare un padre sul come si possa comportare un figlio lontano
e abbandonato, dalla lontananza, alla sua arbitrarietà.
Comprenderai certamente di cosa intendo parlare.
In realtà credo che tu non abbia ragione alcuna di dubitare
del mio comportamento, anche nei riguardi dell'immoralità.
Infatti io detesto e disprezzo nel modo più assoluto tutto ciò
che è volgare e impuro.
Ringraziando la Volontà Divina e ringraziando Te per la ferrea
educazione che mi hai infuso, posso oggi giurare di essere stato forte
finora, e mi riprometto di mantenermi integro anche in avvenire."
Da ciò risulta che quello che molti considerano il più coraggioso, abile,
ammirevole, leggendario capo partigiano, coltivava la virtù della castità
nella continenza, anche per mezzo della Grazia attinta dalla pratica
della Comunione quotidiana....]
Nella squadra che era stata distaccata a sua protezione c'era pure Sergio,
un mitragliere che in montagna per tutti era "Fiore".
In un giorno in cui Lunetti era andato a far visita al cugino, ebbe modo
di notare che Sergio si era intrattenuto molto a lungo con «Bisagno».
Dal colloquio era uscito visibilmente commosso, tutto rosso sulle guance
e con le lacrime agli occhi.
«Lì per lì», ricorda Lunetti, «feci finta di niente, ma fui colpito
da quel legame misterioso e profondo fra i due. Sergio era un bel ragazzo,
alto e fiero, molto sicuro dei suoi mezzi, al punto che fin lì aveva
pensato di bastare a sé stesso. Per dirla in breve: era un ateo convinto,
e tale convinzione gli veniva direttamente dalla famiglia.
Orbene, un mese dopo, la notte stessa in cui "Bisagno" poté lasciare
Casone, ci fu un'incursione a tenaglia degli Alpini della "Monterosa"
che portò alla cattura dell'intera squadra di "Fiore", a eccezione
del portamunizioni.
Poco tempo dopo, otto su nove di quei prigionieri furono passati
per le armi a Chiavari. Fra di essi anche "Fiore", il quale, con
meraviglia di tutti, ma non mia, si seppe poi che, prima di essere
fucilato, aveva chiesto e ottenuto il Battesimo.
Morì gridando "Viva "Bisagno"!».
Questo era il capo partigiano che morì misteriosamente sotto le ruote
di un camion nel pieno della caccia al fascista che si era scatenata
ad opera dei comunisti all'indomani della Liberazione, una caccia
che egli aveva condannato e alla quale si era opposto in ogni maniera,
giudicandola ributtante e demoniaca.
Onorificenze
Medaglia d'oro al valor militare
«Fra i primissimi ad accorrere in difesa della sua terra oppressa dal nemico partecipava a numerose azioni di guerra alla testa dei suoi partigiani che lo avevano eletto capo per l’indomito coraggio e l’alto spirito di sacrificio sempre ed ovunque dimostrati. Audace assertore di azioni di sabotaggio distruggeva con leggendario ardimento e tecnica perfetta importanti opere fortificate avversarie, inseguendo, disperdendo e catturando i nemici atterriti, ma ammirati, dalla sua audacia. Mentre completava la sua missione restituendo alle loro case i partigiani superstiti della lotta, suggellava con la morte la sua giovane eroica esistenza.»
— Desenzano del Garda, 21 maggio 1945
Ad Aldo Gastaldi il comune di Genova ha dedicato un'importante arteria cittadina (rinominando il Corso Giulio Cesare) su cui si affaccia la Casa dello Studente, teatro negli anni della repubblica fascista di efferate torture.

Una statua con lapide a suo ricordo si trova al Parco dell'Acquasola, nel centro cittadino. Sempre a Genova un Istituto Tecnico Industriale porta il suo nome.
Il 24 aprile 2005 i resti mortali di Aldo Gastaldi sono stati traslati dal Campo di Trento e Trieste al Pantheon del Cimitero monumentale di Staglieno, dove riposano i genovesi più illustri.


Nell'anno 2009 Aldo Gastaldi è stato inserito nell'agenda pastorale liturgica di servizio e di memoria della Diocesi di Genova ed annoverato tra coloro che hanno onorato la Chiesa genovese nel XX secolo.








Ultima modifica di Melchisedec; 24-04-12 alle 02:19
-
24-05-12, 01:23 #10Forumista senior

- Data Registrazione
- 15 Dec 2011
- Messaggi
- 2,058
-

- 0
-

- 50
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Thread(s)
 Re: Personaggi memorabili
Re: Personaggi memorabili
IL PASSATO TI TRAPASSA - PANSA RICORDA E BENE LA CAMPAGNA DIFFAMATORIA CHE CONDANNÒ A MORTE LUIGI CALABRESI - “FU UN’AGGRESSIONE SCHIFOSA, DURATA MESI E MESI. UN VELENO CUCINATO E DIFFUSO DALLE TESTE D’UOVO DELLA SINISTRA ITALIANA” - TRA LE 800 FIRME RACCOLTE DA “L’ESPRESSO” NEL 1971: GIORGIO BOCCA, EUGENIO SCALFARI, UMBERTO ECO, DARIO FO, FURIO COLOMBO, BERNARDO BERTOLUCCI, TONI NEGRI, DACIA MARAINI…
Giampaolo Pansa per "Libero"
«Da due anni vivo sotto questa tempesta. Lei non può immaginare che cosa ho passato e che cosa sto passando. Se non fossi cristiano, se non credessi in Dio non saprei come resistere...». Parlava così il commissario Luigi Calabresi qualche settimana prima di essere ucciso.
[Il 17 maggio 1972 alle ore 09:15 il commissario di polizia Luigi Calabresi fu assassinato, davanti alla sua abitazione, mentre si avviava alla sua auto per andare in ufficio, da un commando composto da almeno due sicari che gli spararono alle spalle. Lasciò la moglie Gemma Capra, incinta, e due figli: Mario, che diventerà noto giornalista e scrittore, attuale direttore de La Stampa, e che ha raccontato la storia della sua famiglia nel libro Spingendo la notte più in là e Paolo. Il terzo figlio (Luigi) nascerà pochi mesi dopo la sua morte.]

Come era successo altre volte, lo avevo incontrato nell'ufficio di Antonino Allegra, il capo della sezione politica della questura milanese. Eravamo all'inizio del 1972, lavoravo da inviato della Stampa a Milano. E dalla strage di piazza Fontana in poi, scrivevo di continuo su quella folle stagione di bombe, di morti, di linciaggi.
Domandai a Calabresi se avesse paura. Lui rispose: «Paura no perché ho la coscienza tranquilla. Ma quel che mi fanno è terribile. Potrei farmi trasferire da Milano, però non voglio andarmene. Comunque non ho paura. Ogni mattina esco di casa e vado al lavoro sulla mia Cinquecento, senza pistola e senza la protezione di una scorta. Perché dovrei proteggermi? Sono un commissario di polizia e il mio compito è di proteggere gli altri, i cittadini».
Ero convinto di non dover più scrivere su una storia vecchia di quarant'anni. Ma certe vicende non passano mai. Riemergono di continuo come fantasmi testardi che ti obbligano a guardarli in faccia di nuovo. Accade così per il mattatoio di piazza Fontana, che oggi ha ispirato un film di Mario Tullio Giordana, Romanzo di una strage, nelle sale dal 30 marzo.
Il figlio del commissario, Mario Calabresi, direttore della Stampa, l'ha già visto. E ha osservato che nel film è stata fatta sparire la campagna di linciaggio contro il padre. Fu un'aggressione schifosa, durata mesi e mesi. Un veleno cucinato e diffuso dalle teste d'uovo della sinistra italiana: il meglio del meglio della cultura, dell'accademia, del giornalismo, del cinema. Signore e signori che per anni ci hanno spacciato un mare di bugie. Forti di un'arroganza che quanti di loro sono ancora in vita seguitano a scagliarci addosso.
Il linciaggio si fondava su una convinzione senza prove: il commissario Calabresi sarebbe stato l'assassino di Giuseppe Pinelli. L'anarchico fermato la sera del 12 dicembre 1969 e morto tre sere dopo, cadendo da una finestra dell'ufficio politico della questura milanese. Il corpo di Pinelli non era ancora stato sepolto, quando su Calabresi cominciò a cadere una grandinata di falsità senza vergogna.
Si disse che il commissario gli aveva inflitto un colpo mortale di karate, ma non c'era mai stato nessun colpo. Poi si sostenne Calabresi era un agente della Cia addestrato in America, ma lui non era mai andato negli Stati Uniti. Infine si raccontò che a Pinelli era stato iniettato il siero della verità, ma si trattava soltanto della flebo usata dai barellieri nella speranza di rianimare l'anarchico.
Non era ancora niente rispetto alla tempesta che venne scatenata poco dopo. Oggi si parla spesso di macchine del fango a danno di politici o di big dell'economia. Ma sono scherzi goliardici rispetto a quella allestita contro Calabresi. Fu un congegno mostruoso, destinato a durare più di due anni. Per poi concludersi con l'assassinio.
Al contrario di quel che si crede, il primo passo non venne compiuto dal giornale di Lotta continua. Bensì da due quotidiani della sinistra storica: l'Avanti! del Psi e l'Unità del Pci, affiancati dal settimanale comunista Vie Nuove. Poi entrò in scena un pezzo da novanta: l'Espresso con la sua firma più famosa, Camilla Cederna.

Subito dopo si mossero i lottacontinua di Adriano Sofri e da quel momento la vita del commissario diventò un inferno.
Calabresi querelò Lotta continua, ma ricevette una replica brutale. Sofri & C. spiegarono che a loro non importava nulla del verdetto di un tribunale. Il proletariato avrebbe emesso la propria sentenza, per poi eseguirla in piazza: "Sappiamo che l'eliminazione di un poliziotto non libererà gli sfruttati. Ma è questa, sicuramente, una tappa fondamentale dell'assalto dei proletari contro lo Stato assassino".
Nel frattempo, il commissario e la sua famiglia venivano inchiodati a una via crucis orrenda. Manifesti su tutti i muri di Milano e di molte città italiane gridavano: Calabresi wanted, ricercato, con l'indicazione della somma da saldare a chi l'avesse catturato. Promesse di morte urlate nei cortei: Calabresi sarai suicidato! Insulti carogna: il commissario Finestra, il commissario Cavalcioni. Vignette bestiali: Calabresi insegna alla figlia piccola come tagliare la testa alla bambola anarchica con una ghigliottina giocattolo. E poi una bufera di lettere anonime, spedite all'indirizzo di casa. Telefonate orrende.
Centinaia di articoli per indicarlo al disprezzo e alla vendetta. Nulla gli fu risparmiato. Quando lo promossero commissario capo, Milano venne tappezzata di nuovi manifesti che lo mostravano con le mani grondanti sangue. Lo slogan gridava: "Così lo Stato assassino premia i suoi sicari".
Ma il culmine dell'infamia fu toccato con la parata firmaiola che dilagò sulle pagine dell'Espresso per tre settimane, a partire dal 13 giugno 1971. Ben ottocento eccellenze di sinistra: filosofi, registi, scienziati, editori, storici, architetti, pittori, scrittori, politici, sindacalisti e un buon numero di giornalisti. Tutti in preda alla certezza che Calabresi fosse un torturatore e un omicida.
Rileggere oggi quell'elenco mi provoca un disgusto profondo per chi l'ha sottoscritto. Mi ero ben guardato dal firmarlo, anche se le insistenze dei promotori mi pungolavano a farlo. Avevo scritto su piazza Fontana sin dal primo giorno. E in qualche modo rappresentavo la Stampa a Milano. Però mi ripugnava il ritratto che veniva dipinto di Calabresi. Lo ritenevo falso da cima a fondo. Inoltre volevo sottrarmi all'aria pessima che tirava a Milano.
Era un'aria che puzzava di faziosità sfrenata, di furibondo partito preso, di certezze proclamate con il sangue agli occhi, di dubbi rifiutati con disprezzo. In quel clima, se non partecipavi al linciaggio di Calabresi una penale la pagavi. Ti accusavano di schierarti con i fascisti, cercavi i favori della polizia, facevi un giornalismo prezzolato, stavi al servizio della Direzione affari riservati del Viminale.
Un altro che, strano a dirsi, non firmò fu Adriano Sofri. Tanti anni dopo, nel libro La notte che Pinelli, pubblicato nel 2009 da Sellerio, spiegò la faccenda così: «Io non ero tra i firmatari. Nessuno me lo chiese, e con la boria e la faziosità di allora me ne sarei guardato. Era un testo molto duro e si pronunciava con indebita sicurezza».
In calce a quel libro, con sottile perfidia, Sofri ha pubblicato l'elenco delle ottocento firme. Scorrerle una per una, ti induce a pensare che la "meglio gioventù" partorita dal Sessantotto aveva alle spalle il peggio del vippume di sinistra.
Molte di quelle eccellenze sono scomparse, a cominciare da Norberto Bobbio per finire a Giorgio Bocca. Ma tanti big sono ancora in vita. E da ben poco venerati maestri seguitano a impartirci lezioni burbanzose. Qualche nome? Eugenio Scalfari, Umberto Eco, Dario Fo, Furio Colombo, Lucio Villari, Bernardo Bertolucci, Toni Negri, Dacia Maraini... Basta, mi fermo qui. Forse è vero che stiamo diventando un paese per vecchi, a cominciare da me. Ma un po' di pudore non farebbe male a nessuno.
[Fra gli ottocento intellettuali (ripeto: ottocento) che firmarono il documento pubblicato dall'Espresso il 13 giugno 1971, dove Calabresi veniva definito (ingiustamente!) «commissario torturatore» e il «responsabile della fine di Pinelli», oltre al giovane Paolo Mieli, troviamo i più attempati Norberto Bobbio, Alberto Moravia, Umberto Eco, Dario Fo, Eugenio Scalfari, Giorgio Bocca, Furio Colombo, Livio Zanetti, Pier Paolo Pasolini, Lucio Colletti, Carlo Rossella, Toni Negri, Camilla Cederna, Tiziano Terzani, Massimo Teodori, Giorgio Amendola, Giancarlo Pajetta, Federico Fellini, Mario Soldati, Cesare Zavattini, Carlo Rognoni, Bernardo Bertolucci, Carlo Lizzani, Liliana Cavani, Luigi Comencini, Paolo e Vittorio Taviani, Gillo Pontecorvo, Marco Bellocchio, Ugo Gregoretti, Nanni Loy, Giovanni Raboni, Giovanni Giudici, Renato Guttuso, Andrea Cascella, Ernesto Treccani, Emilio Vedova, Carlo Levi, Vito Laterza, Giulio Einaudi, Inge Feltrinelli, Franco Antonicelli, Lucio Villari, Paolo Spriano, Giulio Carlo Argan, Fernanda Pivano, Gillo Dorfles, Morando Morandini, Luigi Nono, Margherita Hack, Gae Aulenti, Giò Pomodoro, Paolo Portoghesi, Dacia Maraini, Enzo Siciliano, Alberto Bevilacqua, Franco Fortini, Angelo M. Ripellino, Natalino Sapegno, Primo Levi, Enzo Enriques Agnoletti, Lalla Romano, Giorgio Benvenuto, Pierre Carniti, Sergio Saviane, Giuseppe Turani, Carlo Mazzarella, Andrea Barbato, Vittorio Gorresio, Bruno Zevi, Grazia Neri, Franco Basaglia, Carlo e Vittorio Ripa di Meana, Paola Pitagora. ]
Dalla Chiesa cattolica Calabresi è considerato un servo di Dio, martire per la giustizia, le cui qualità cristiane furono riconosciute da Papa Paolo VI. "Testimone del Vangelo e eroico difensore del bene comune" per Giovanni Paolo II, è iniziato anche un processo di beatificazione, ad opera del sacerdote Ennio Innocenti. La fede cristiana del commissario, trova origine sin nella partecipazione giovanile al movimento "Oasi" di padre Virginio Rotondi.
A 35 anni dall'assassinio nuove testimonianze sulla fede del poliziotto.
Faceva parte dell'«Oasi» di padre Rotondi, per due volte pensò alla
vocazione sacerdotale e s'arruolò per fare il bene in un ambiente difficile.
Enzo Tortora: «Credeva fermamente in Dio»
Calabresi, un'aureola per il commissario
Di Roberto Beretta
«Credeva in Dio, fermamente. Quando una volta gli chiesi, nel periodo più
buio delle accuse, degli attacchi, degli insulti, come faceva a resistere,
senza mai un cedimento di nervi, senza uno scatto, a quell'autentico
linciaggio morale a cui era sottoposto, mi rispose sorridendo: "È semplice.
Credo in Dio. E credo nella mia buona fede. Non ho mai fatto nulla di cui
possa vergognarmi. E non odio nemmeno i miei nemici; ho angoscia per loro,
non odio. È una parola - odio - che proprio non conosco».
Così scriveva Enzo Tortora (sì, proprio il giornalista di Portobello, poi
divenuto a sua volta vittima di un altro linciaggio morale) il giorno dopo
la morte del commissario Calabresi. Lui, che non era credente, e all'epoca
faceva il cronista nella Milano delle incipienti trame terroristiche,
racconta di aver voluto tempo prima conoscere «intimamente, al di là cioè
dei rapporti di lavoro» quel giovane funzionario di polizia e di aver
scoperto così «un ragazzo di incredibile bontà, di un rigore morale, di uno
scrupolo e di una umanità che lo allontanavano le mille miglia dal ruolo di
"sbirro"». Perché Luigi Calabresi era un cristiano convinto, impegnato; e -
se non lo ostentava - non aveva nemmeno paura di affermarlo, come nella
tavola rotonda registrata nel 1966 per il settimanale Epoca e di cui
pubblichiamo qui a fianco alcuni stralci.
La fede l'aveva ereditata in famiglia, certo (era della parrocchia di Santa
Pudenziana a Roma, dove esercitava il futuro arcivescovo Carlo Maccari,
e frequentò scuole cattoliche), ma soprattutto la incontrò nei primi anni
Sessanta - il periodo dell'università - nel movimento «Oasi» di padre
Virginio Rotondi. Sia il fondatore, sia il suo confessore don Ennio
Innocenti hanno scritto testimonianze decise sulla convinzione del giovane
Luigi: «Era il migliore fra tutti, per chiarezza di idee, per profondità di riflessioni».
Per due volte si esaminò per lui la possibilità di una vocazione sacerdotale.
Ma anche l'orientamento a entrare in Polizia dipese dal consiglio del direttore
spirituale (padre Rotondi lo avrebbe poi voluto nel presidio del Quirinale) e dal
desiderio di compiere il bene in un ambiente difficile: «Anche nella Polizia
c'è bisogno di testimonianza cristiana», disse una volta Calabresi.
Non per niente i suoi metodi erano spesso diversi da quelli dei colleghi,
e talvolta il capo lo rimproverava di condurre gli interrogatori con troppo agio
per gli indiziati.
Anche quando Camilla Cederna orchestrò la terribile campagna di stampa contro di lui,
condita da molte menzogne, il bersaglio così si confidava col giornalista Giampaolo Pansa:
«Se non fossi cristiano, se non credessi in Dio, non so come potrei resistere».
Il commissario fu ucciso il 17 maggio 1972, a 34 anni. Adesso che su di lui è avviato
un processo di beatificazione, lo storico Giordano Brunettin raduna molte testimonianze
nella nuova edizione del suo Luigi Calabresi. Un profilo per la storia. C'è il giovane Calabresi
che a Roma «convince» i preti adescati da prostitute a lasciar perdere. Il neo-sposo che,
dopo aver visto Fratello sole sorella luna di Zeffirelli, affronta il francescano padre Eligio
per difendere l'immagine del Poverello. E ovunque risalta l'immagine di un cristiano
che ci credeva davvero; e lo diceva anche. Come scrisse ancora Tortora:
«Vedrai - mi diceva qualche volta -. Vedrai che un giorno o l'altro ti capita di incontrarlo, Dio».



Discussioni Simili
-
Personaggi
Di Supermario nel forum Archivio della Comunità di PolRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-02-10, 21:39 -
In che personaggi...
Di Skarm nel forum Il Seggio ElettoraleRisposte: 29Ultimo Messaggio: 29-03-07, 19:48 -
Personaggi da NON votare
Di Ashmael nel forum Il Termometro PoliticoRisposte: 20Ultimo Messaggio: 14-09-05, 11:57 -
Personaggi
Di Sgiar nel forum FumettiRisposte: 29Ultimo Messaggio: 04-09-05, 12:06 -
Detti memorabili di Ariel Sharon
Di gianniguelfi nel forum Centrodestra ItalianoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-04-04, 16:46

















 Rispondi Citando
Rispondi Citando

